Il 22 dicembre non è arrivata nessuna notifica pubblica, nessun comunicato, nessuna ammissione. È arrivato soltanto un fatto, nudo e persino irritante nella sua semplicità: Meta ha riattivato i profili di Matrice Digitale che erano stati chiusi il 1° ottobre. La piattaforma che nel racconto pubblico viene descritta come un soggetto privato, lontano, impersonale, automatizzato, ha fatto ciò che in teoria dovrebbe fare un sistema di garanzie: ha rimesso in piedi un’identità digitale, ha restituito un canale informativo, ha riaperto una porta che per due mesi era rimasta sbarrata.
E così, per paradosso, nel giorno in cui la redazione torna a respirare sui social, la domanda più scomoda non riguarda l’algoritmo, ma lo Stato.
Perché, se il potere che ti riabilita è lo stesso che ti ha punito, e se nel mezzo non esiste alcuna catena pubblica di responsabilità, allora non stiamo parlando di moderazione dei contenuti. Stiamo parlando di dipendenza strutturale. E non è una metafora: è esattamente la dinamica di un ecosistema in cui l’accesso allo spazio pubblico digitale non viene garantito da procedure trasparenti e contestabili, ma da decisioni opache, reversibili, inappellabili, e soprattutto private.
L’inchiesta comincia qui: non dal blocco in sé, ma da ciò che è emerso dopo. Il blocco è il sintomo. Il problema è la reazione, o meglio l’assenza di reazione, delle Istituzioni che dovrebbero presidiare un mercato informativo che ormai coincide con l’infrastruttura della democrazia.
Il ban “per truffe e raggiri”: quando la reputazione viene riscritta dall’algoritmo
La chiusura dei profili non è stata un inciampo tecnico, non è stata una sospensione da chiarire in poche ore. È stata descritta con un’accusa pesante, delegittimante, quasi infamante: truffe e raggiri ai danni degli utenti, secondo la qualificazione usata dalla società di Mark Zuckerberg. E questa formula, nella realtà concreta di un direttore giornalistico e di una testata registrata, ha un effetto immediato: sporca, isola, rompe i legami, interrompe la distribuzione, riduce l’affidabilità percepita, trasforma un’attività editoriale in un profilo “a rischio”.
E qui la vicenda cambia natura. Perché quando una piattaforma appiccica a un soggetto giornalistico un’etichetta del genere, non sta solo applicando regole interne. Sta producendo una narrazione pubblica, sta riscrivendo la reputazione senza processo e senza contraddittorio. È un potere enorme, perché la reputazione non è più un concetto morale: è un dato operativo. È ciò che decide la reach, le segnalazioni, i filtri, le verifiche, l’accessibilità. È ciò che decide se esisti.
C’è stato, nel racconto che emerge da questa storia, un passaggio ancora più surreale: una settimana di sospensione e verifica, poi non una riattivazione, ma un verdetto più duro: ban permanente. Come si arriva a una soluzione del genere? Quali elementi sono stati valutati? Quale contestazione è stata presa in carico? Quale atto è stato prodotto?
Qui non c’è nulla da ricostruire con i documenti, perché la piattaforma non produce documenti nel senso in cui li produce uno Stato. Produce notifiche, categorie, pulsanti. Produce “decisioni” senza firma. E questo è il primo punto: la piattaforma esercita potere amministrativo senza procedura amministrativa. Se sei un cittadino o una testata, ti resta una sola cosa: bussare ovunque, sperando che qualcuno apra.
Lo scandalo del Garante e il contesto che rende tutto più grave
La sospensione non avviene nel vuoto. Avviene mentre la testata racconta, nel proprio lavoro, ciò che definisce “lo scandalo del Garante privacy”, e lo fa in un contesto in cui Matrice Digitale percepisce di essere stata tra le poche voci a parlarne con continuità, nei mesi precedenti alle incursioni televisive e alle inchieste che hanno allargato la platea.
Questo elemento non va trasformato in un teorema automatico. Nessuno può dimostrare, nel modo in cui si dimostra un fatto processuale, un nesso diretto tra un’inchiesta e un ban. Eppure l’elemento giornalistico resta: il ban accade nel pieno di un contesto ad alta tensione informativa, e la piattaforma motiva il blocco con un’accusa che colpisce la credibilità. In un ecosistema dove la distribuzione delle notizie dipende dagli algoritmi, il tempismo è già una forma di potere.
È in questo quadro che nasce l’azione più razionale possibile: scrivere alle istituzioni. Non per chiedere favori, ma per chiedere orientamento, assistenza, tutela. Se un soggetto giornalistico viene estromesso dalle principali piazze digitali sulla base di un’etichetta infamante, il sistema pubblico dovrebbe avere un canale, un percorso, un punto di contatto.
Ed è qui che l’inchiesta trova il suo nucleo: ciò che risponde lo Stato, e ciò che non risponde.
La mail alle autorità: il test che misura la distanza tra cittadino e istituzioni
Matrice Digitale invia una lettera alle istituzioni preposte al controllo del mercato e alla tutela. È un gesto che sembra perfino ovvio, in un Paese dove le autorità indipendenti sono nate proprio per presidiare gli spazi in cui il cittadino non può trattare da pari con una multinazionale. Ma il risultato, nel racconto, è eloquente: le risposte sono poche, tardive, e soprattutto evasive. Non nel senso umano del termine, ma nel senso tecnico: non indicano una presa in carico.
Qui si produce una frattura che vale più del caso specifico. Perché quando un cittadino si rivolge alle Istituzioni e scopre che il perimetro delle competenze è un labirinto, il messaggio implicito diventa devastante: sei solo. E quando sei solo, la tua unica possibilità è tornare a negoziare con chi ti ha colpito.
Non con lo Stato, ma con l’azienda.
È questo il cuore politico, prima ancora che giornalistico, della vicenda: l’asimmetria totale tra la velocità operativa delle piattaforme e la lentezza, o l’inerzia, dei presìdi pubblici. In quella asimmetria si annida un rischio: non solo di censura, ma di normalizzazione dell’impotenza. Ti abitui al fatto che le Istituzioni non rispondono. Ti abitui al fatto che non esistano strumenti. E alla fine ti muovi come se l’unico potere reale fosse quello privato.
Il primo a rispondere “non è competenza nostra” è il Garante Privacy
Il dato più sorprendente è che proprio il Garante per la protezione dei dati personali, travolto dal proprio turbine mediatico e istituzionale, è stato il primo a rispondere. Un dirigente, Lippi, risponde e chiarisce un punto: il tema non rientra nel perimetro dell’Autorità, perché non riguarda la tutela e la protezione dei dati nel senso strettamente normativo.
Questo passaggio va letto con attenzione. Da un lato, è un atto di correttezza istituzionale: un’Autorità non può inventarsi competenze. Dall’altro lato, è un segnale drammatico: perché se il cittadino vede violata la propria presenza digitale e la propria reputazione attraverso una decisione algoritmica, e il Garante non può intervenire, allora chi può?
È la domanda che resta sospesa. Ed è qui che la storia prende la forma di una radiografia: la cittadinanza digitale è un territorio enorme, ma le competenze pubbliche sono frammentate. Le piattaforme operano in modo integrato, le autorità rispondono per compartimenti.
E in mezzo c’è il giornalismo, che non è un utente qualunque. È un presidio costituzionale, una funzione pubblica esercitata da privati. Se una testata viene spenta, anche temporaneamente, non perde solo traffico: perde il diritto di parlare in un’arena che, di fatto, è diventata infrastruttura del dibattito pubblico.
Lo studio legale che rappresenta Meta: “non siamo responsabili”
Nello stesso giorno, “poco dopo”, risponde anche lo studio che rappresenta in Italia gli interessi di Meta. E la risposta è un’altra forma di non presa in carico: non siamo responsabili della società per le vicende che riguardano le contestazioni. È una frase che, tradotta in esperienza concreta, significa: non è qui che trovi soluzione, non è qui che trovi interlocuzione.
La combinazione delle due risposte produce una sensazione di vuoto perfetto. Da un lato l’autorità pubblica dice “non è competenza nostra”. Dall’altro il rappresentante degli interessi privati dice “non dipende da noi”. Nel mezzo, la piattaforma continua a esercitare il potere, e l’utente resta sospeso.
È in questa zona grigia che nascono le dipendenze informali, le mediazioni non dichiarate, i “contatti”, le scorciatoie. Perché se la procedura non esiste, la soluzione diventa relazione. E quando la soluzione diventa relazione, la democrazia digitale smette di essere un diritto e diventa un privilegio negoziato.
Agcom risponde dopo 60 giorni: c’è un modulo. E la soluzione diventa burocrazia
Dopo circa due mesi arriva anche una risposta dell’Agcom. Non una presa in carico del caso, ma un’indicazione: c’è un modulo sul sito da compilare per formulare una contestazione. È una risposta che, per quanto legittima sul piano formale, fotografa un altro squilibrio: mentre la piattaforma decide in pochi secondi, la tutela pubblica ti chiede un percorso che spesso si traduce in tempi lunghi, passaggi incerti, esiti imprevedibili e nel mercato digitale ed editoriale più tempo passa nell’oblio una impresa, una testata, più muore in un cimitero che già sconvolge l’intero settore.
In altre parole: la piattaforma è potere in tempo reale. Lo Stato è tutela differita. Ma la cittadinanza digitale non vive nel differito: vive nella continuità. Se un giornale viene spento per due mesi, l’effetto è immediato e spesso irreversibile. La perdita di pubblico e di distribuzione non si recupera con un modulo.
Eppure questa risposta, come quella del Garante, è importante, perché è almeno un segnale di esistenza. È come se, in un deserto, anche un cartello sbiadito fosse un sollievo. Ma il punto giornalistico non è ringraziare per l’acqua. È chiedere perché il deserto esiste.
Il secondo caso: Google chiude il profilo del direttore con accuse “ancora più infamanti”
Dentro la stessa vicenda emerge un altro fronte, che amplia l’inchiesta: Google ha chiuso il profilo giornalistico del direttore, quello che pubblica contenuti e link di Matrice Digitale, con accuse ancora più pesanti: vendita di farmaci da prescrizione, promozione di armi, traffico. Se questo quadro viene confermato, siamo davanti a un meccanismo ricorrente: l’etichetta non serve a spiegare, serve a neutralizzare.
Perché non c’è modo più efficiente di silenziare una voce che non sia spegnerla e basta. Spegnerla con un’accusa infamante, così che perfino la solidarietà si raffreddi. Nessuno vuole esporsi per chi è “accusato” di certe cose, anche se l’accusa è automatica, anche se è chiaramente incompatibile con la natura dell’attività giornalistica. Va citato anche che l’unico quotidiano ad aver dato voce a questo scandalo democratico dei tempi nostri è stato il Fatto Quotidiano con un pezzo firmato dal prof. Andrea Lisi.
Questa parte, quella di YouTube, verrà approfondita, anche per un’altra ragione: Google è descritta come la società con più relazioni con il governo italiano, e il governo sarebbe stato informato della chiusura del profilo social. Qui l’inchiesta prende un taglio istituzionale: non si tratta più solo di moderazione o account ban, ma di rapporti tra piattaforme e potere pubblico, di canali informali, di interlocuzioni privilegiate.
Ed è qui che si apre un tema che supera Matrice Digitale:
se le piattaforme hanno canali diretti con i governi, mentre i cittadini e le testate non riescono a ottenere risposte dalle autorità, allora la “cittadinanza digitale” non è uguale per tutti. È graduata. È gerarchica. È selettiva.
L’Ordine dei giornalisti: nessuna tutela, ma la quota arriva puntuale
C’è un passaggio “simpatico”, ma in realtà è tragico. L’Ordine dei giornalisti campano viene informato della vicenda unitamente a quello nazionale. Non arriva una risposta nel merito, non arriva una forma di tutela, non arriva una presa in carico visibile. Ma arriva puntuale la richiesta di pagamento della quota: 90 euro per i professionisti.
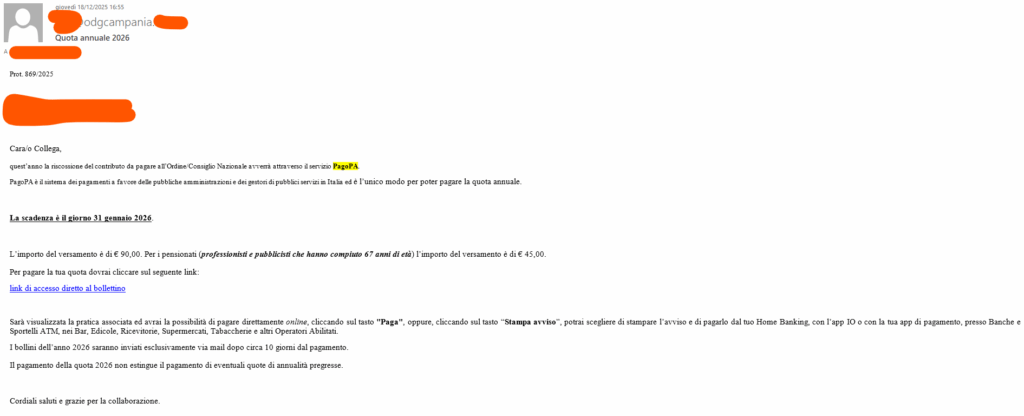
Non è una polemica economica. È un simbolo. Perché l’Ordine, nel senso storico del termine, dovrebbe essere una delle poche strutture in grado di agire come presidio collettivo, soprattutto in un’epoca in cui il giornalismo viene non solo attaccato fisicamente o legalmente, ma anche silenziato e delegittimato dagli algoritmi. Se l’Ordine non ha strumenti, o non li usa, o non ha una proposta credibile, allora resta un ente che certifica e incassa, mentre il mercato informativo si sposta su territori dove la certificazione serve a nulla.
È un cortocircuito perfetto: la legittimazione professionale viene garantita dallo Stato, ma la possibilità di esistere nel dibattito pubblico viene concessa o negata da piattaforme private. E in mezzo, chi dovrebbe rappresentare la categoria appare disarmato.
Chi ha sbloccato davvero Matrice Digitale? La domanda che resta senza risposta
Non sappiamo chi abbia sbloccato i profili su Meta. Oppure forse lo sappiamo. È la forma più onesta con cui si può descrivere un sistema opaco: le soluzioni arrivano, ma non si capisce come. E se non capisci come, non puoi replicare. Se non puoi replicare, non hai diritto: hai fortuna.
Questo è il punto che trasforma una vicenda personale in un caso pubblico. Perché la domanda non riguarda Matrice Digitale. Riguarda il Paese. Riguarda il funzionamento della tutela. Riguarda la filiera della responsabilità.

Se un profilo viene chiuso con l’accusa di truffa e poi riaperto senza spiegazioni, non è un lieto fine. È un campanello. Perché significa che l’errore può esistere, e se l’errore esiste allora la piattaforma può colpire chiunque. Significa anche che la rettifica non è un atto dovuto, ma un evento. E quando la rettifica è un evento, la cittadinanza digitale somiglia più a una lotteria che a un diritto.
La “logica della mafia”: quando la tutela diventa dipendenza dal privato
Chiediamo scusa al lettore per l’uso di un’analogia forte, volutamente disturbante, circa la logica per cui i cittadini non trovano lo Stato e si rivolgono alla mafia, e dunque, per analogia, i cittadini che non trovano giustizia e regole certe si rivolgono a un potere privato che almeno produce effetti.
Non è un’accusa letterale. È una metafora politica, e come tutte le metafore politiche serve a illuminare un punto: la sostituzione funzionale. Se lo Stato non riesce a garantire tempi, canali, risposte e tutele, allora qualunque altro attore capace di produrre risultati diventa, per necessità, un riferimento. Non perché sia giusto, ma perché è efficace.
E qui sta la vera paura di questa storia: non che Meta sblocchi o blocchi. Ma che questa dinamica diventi normale. Che un giornale, un cittadino, un professionista, impari che per esistere deve sperare nella benevolenza di un sistema privato, o deve trovare mediazioni, o deve conoscere qualcuno, o deve “parlare con l’algoritmo” come si parla con un ufficio pubblico. Solo che non è un ufficio pubblico. Non ha obblighi. Non ha contraddittorio. Non ha trasparenza.
E così, mentre si celebra il ritorno dei profili, resta una frase che pesa più di tutte: il ruolo di Meta è stato più rappresentativo degli interessi privatistici dinanzi alle istanze giunte. Tradotto: l’unico soggetto che ha agito concretamente è stato quello che agisce per sé. Le istituzioni, quelle che dovrebbero agire per noi, hanno risposto tardi, poco, o non hanno risposto affatto.
Questa non è solo una storia di social network. È una storia di mercato, di potere, di cittadinanza e di giornalismo. È la fotografia di un Paese in cui le infrastrutture della parola pubblica sono private, e le tutele pubbliche sono frammentate, lente, incerte. È la fotografia di un’epoca in cui la libertà di informare non viene colpita necessariamente con la censura esplicita, ma con l’interruzione amministrativa automatizzata, accompagnata da etichette infamanti che nessuno firma.
E se oggi è capitato a una testata, domani può capitare a un sindacato, a un’associazione, a un ricercatore, a un whistleblower, a un giornalista scomodo, a un cittadino che semplicemente parla oppure scrive troppo.
Iscriviti alla Newsletter
Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.
Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.









