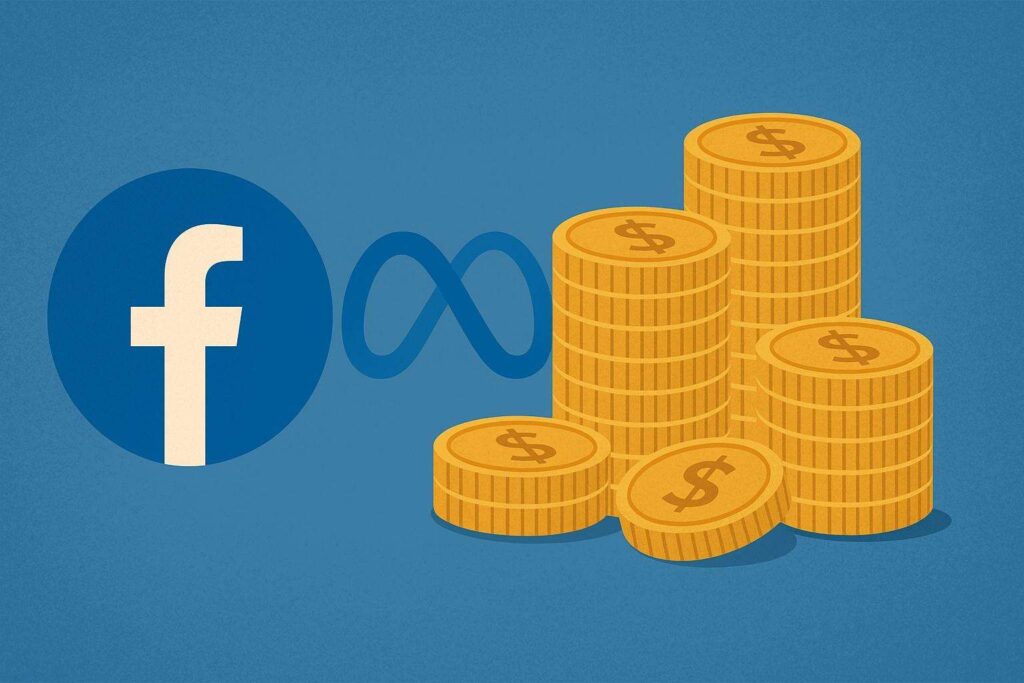Agcom ordina a Meta di versare circa 10 milioni di euro al gruppo Gedi per l’uso di articoli giornalistici su Facebook nel 2022, stabilendo un precedente nell’equo compenso per i diritti editoriali. La decisione nasce da un procedimento avviato dopo il mancato accordo tra le parti. Agcom applica il regolamento del 2023, che recepisce l’articolo 43-bis della legge sul copyright. Il compenso viene calcolato in base ai ricavi pubblicitari di Meta generati grazie ai contenuti di Gedi, sottraendo i benefici di traffico di ritorno ottenuti dall’editore. Gedi, proprietario di testate come Repubblica e La Stampa, riceve una somma ben superiore ai 9 milioni di euro, lontana dai 30 milioni inizialmente richiesti e decisamente superiore all’offerta di Meta inferiore a 40.000 euro. La commissaria Elisa Giomi vota contro, contestando l’aliquota del 70% come fattore polarizzante. La delibera, approvata il 10 luglio 2025, arriva nello stesso giorno in cui l’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue esprime parere favorevole sulla compatibilità con la direttiva europea. Meta può ricorrere al Tar. Si tratta del primo intervento normativo su un social network, rafforzando il ruolo di Agcom come arbitro nei rapporti tra editori e piattaforme digitali. Il settore editoriale ottiene così una forma di tutela contro l’utilizzo gratuito e non autorizzato dei propri contenuti da parte dei giganti del web. Facebook, pur generando traffico verso le testate, utilizza i contenuti per scopi pubblicitari diretti. Agcom ha valutato fattori come l’audience, la rilevanza editoriale e gli investimenti tecnologici. La decisione rappresenta un punto di equilibrio tra innovazione digitale e remunerazione giornalistica.
La decisione di Agcom sul compenso
Agcom approva la delibera il 10 luglio 2025, obbligando Meta al pagamento di un compenso a Gedi per l’utilizzo delle sue pubblicazioni su Facebook. Il provvedimento si basa sul regolamento n. 3/23/CONS, che recepisce l’articolo 43-bis della legge italiana sul copyright, stabilendo i criteri dell’equo compenso. Dopo il fallimento delle trattative tra le parti, Agcom è intervenuta come autorità garante, valutando in modo indipendente le proposte economiche presentate. Nessuna delle due — né quella di Gedi né quella di Meta — è stata ritenuta coerente con i parametri stabiliti. La determinazione del compenso si è basata sui ricavi pubblicitari netti di Meta derivanti dai contenuti giornalistici di Gedi, al netto dei benefici di ritorno per l’editore. L’aliquota del 70% è stata applicata in base a un insieme di criteri: la quantità di consultazioni online su Facebook, la rilevanza delle testate di Gedi nel panorama nazionale, il numero di giornalisti assunti con contratto collettivo nazionale, e gli investimenti tecnologici documentati. Sono stati considerati anche i costi di Meta per la riproduzione dei contenuti e la sua adesione a standard internazionali. Una nota metodologica accompagna la delibera, definendo criteri e servizi rilevanti. La decisione, pur con il dissenso della commissaria Giomi, stabilisce un precedente per i social network, aprendo la strada a nuove tutele per gli editori.
Il calcolo dettagliato dell’equo compenso
Il calcolo dell’equo compenso parte dai ricavi pubblicitari netti che Meta ha realizzato nel 2022 sfruttando i contenuti di Gedi. A questi viene sottratto il valore generato dal traffico di ritorno. Su tale base si applica l’aliquota del 70%, definita come massima in funzione della rilevanza del contenuto. L’importo finale si attesta intorno ai 10 milioni di euro. Gedi aveva inizialmente richiesto 30 milioni, includendo anche i contenuti su Instagram, mentre Meta aveva offerto meno di 40.000 euro. La discrepanza ha spinto Agcom a fissare un valore indipendente, usando criteri oggettivi. Tra questi, il numero di consultazioni su Facebook, l’audience online di Gedi, il numero di giornalisti impiegati, e i costi per infrastrutture digitali. La nota metodologica fornisce istruzioni chiare: vengono esclusi i ricavi non legati a contenuti giornalistici e vengono pesati fattori come l’anzianità delle testate, l’impegno nel fact-checking, l’adesione ai codici deontologici. La commissaria Giomi ha criticato la rigidità del 70%, temendo effetti polarizzanti e tensioni legali. Tuttavia, l’obiettivo dichiarato di Agcom è quello di garantire un equilibrio economico tra chi genera valore e chi ne trae profitto. Il metodo, ritenuto trasparente e replicabile, è destinato a essere utilizzato anche per casi futuri.
Le reazioni delle parti coinvolte
La commissaria Elisa Giomi ha votato contro la delibera, giudicando l’aliquota del 70% eccessivamente rigida e causa di polarizzazione. Nonostante il dissenso, Agcom ha approvato il provvedimento con una maggioranza. Gedi non ha rilasciato commenti ufficiali, ma la decisione rappresenta un importante successo economico e simbolico per il gruppo editoriale, che potrà ora investire le nuove risorse in qualità e innovazione. Meta, invece, ha mantenuto il silenzio, ma ha la possibilità di ricorrere al Tar, contestando in particolare l’obbligo di condivisione dei dati richiesti da Agcom. Per l’azienda statunitense, la questione della trasparenza algoritmica è più critica del pagamento in sé. La Federazione nazionale della stampa italiana ha accolto positivamente la notizia, considerandola un passo avanti nella tutela dei diritti giornalistici. L’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, lo stesso giorno, ha emesso un parere favorevole sulla compatibilità del meccanismo italiano con la direttiva europea sul copyright. In attesa della sentenza definitiva della Corte di giustizia, il dibattito resta acceso. Il caso attira attenzione internazionale. Mentre gli editori esultano, le big tech temono un effetto domino in Europa. L’opinione pubblica accoglie positivamente l’idea di un’informazione pagata e verificata, a fronte di un’epoca segnata dalla disinformazione.
Implicazioni per il settore editoriale italiano
La decisione rappresenta un punto di svolta per l’editoria italiana. Con i circa 10 milioni di euro ricevuti, salvo ricorsi e contro ricorsi, Gedi può affrontare con maggiore solidità la transizione digitale e sostenere nuovi investimenti. Altri gruppi editoriali stanno preparando richieste analoghe, incoraggiati dal precedente normativo. Il provvedimento di Agcom offre una base concreta per compensi equi e contribuisce a riequilibrare il rapporto tra piattaforme tecnologiche ed editori. Ne derivano benefici non solo per i grandi gruppi, ma anche per i piccoli editori, che potranno fare leva sugli stessi criteri. La disponibilità di fondi aggiuntivi potrà rafforzare il fact-checking, aumentare le assunzioni e migliorare la qualità complessiva dell’informazione. Gli accordi volontari potrebbero aumentare, evitando arbitrati costosi. Facebook, intanto, potrebbe adattare i suoi algoritmi, modificando la visibilità dei contenuti giornalistici. Questo comporta nuove dinamiche anche per l’engagement. Nel lungo termine, la qualità dell’offerta editoriale dovrebbe migliorare, mentre gli editori riducono la dipendenza dalle piattaforme e puntano su canali proprietari. L’Italia, con questo intervento, si pone all’avanguardia in Europa.
Il contesto legale europeo e nazionale
L’articolo 43-bis della legge italiana recepisce la direttiva europea 2019/790 sul copyright, stabilendo l’obbligo di equo compenso per l’uso online di contenuti giornalistici. Il regolamento Agcom del 2023 ha reso operativi i criteri. La questione è oggetto di una valutazione preliminare presso la Corte di giustizia europea, attivata dal Tar del Lazio. Il parere dell’Avvocato generale Ue, favorevole alla normativa italiana, rafforza la posizione dell’autorità italiana. In passato, Agcom ha già imposto a Microsoft il pagamento di 730.000 euro a Gedi per l’uso dei contenuti su Bing, ma il caso Meta rappresenta il primo provvedimento su un social network. A livello europeo, altri paesi come Francia e Germania stanno implementando modelli simili, con accordi privati o imposizioni statali. In parallelo, le questioni di privacy legate al GDPR complicano l’accesso ai dati necessari per il calcolo dei compensi. Tuttavia, Agcom ha definito un approccio che cerca di bilanciare tutela della privacy e trasparenza dei dati.
Casi precedenti e confronti
Nel 2024, Agcom ha imposto a Microsoft un compenso di 730.000 euro a Gedi per i contenuti visualizzati su Bing nel biennio 2021-2022. In quel caso, la somma più contenuta rifletteva il minor impatto della piattaforma rispetto a Facebook. In altri paesi europei, la situazione è in evoluzione: in Francia, Google ha accettato di pagare compensi agli editori, mentre in Germania sono emersi modelli misti con accordi volontari. L’Italia si distingue per l’intervento rapido e strutturato di Agcom, che fissa parametri chiari e replicabili. A livello globale, solo l’Australia ha varato una legge simile con il News Bargaining Code, che ha costretto piattaforme come Facebook e Google a negoziare con i media locali. Il caso Meta-Gedi rappresenta quindi un precedente giuridico forte che potrebbe essere usato da altri editori per avviare procedure simili.
L’equo compenso secondo Agcom e il paradosso Gedi-Meta: un giro contabile tra alleati
La posizione di Matrice Digitale, negli anni, è sempre stata ferma e critica nei confronti delle piattaforme social, in particolare verso l’ambiguità operativa di Meta, che ha non solo ridotto la visibilità degli editori ma, in più occasioni, ha anche esercitato censura selettiva nei confronti dei contenuti giornalistici. Dietro la retorica della “trasparenza algoritmica”, Meta ha perpetuato una dinamica opaca: gli editori che non investono in sponsorizzazioni sulle sue piattaforme vengono sistematicamente oscurati e quelli che investono non superano nel migliore dei casi il pareggio tra costi e ricavi.
In questo scenario, ciò che Agcom ha deliberato non rappresenta solo un pagamento per l’uso di contenuti tutelati da copyright, ma anche un implicito riconoscimento della distorsione di sistema a cui il mondo dell’informazione è stato costretto a sottostare: una bolla di censura regolata da parametri univoci di fact-checking, piegati a una direzione politica evidente.
È importante evidenziare una contraddizione sostanziale: Gedi, tra le poche testate italiane ad aver firmato accordi privati con Meta negli ultimi dieci anni, ha beneficiato in modo diretto del traffico e dei fondi dell’ecosistema social, ma oggi risulta in vendita da parte di John Elkann, che siede nel board della stessa Meta Platforms Inc. Ci troviamo, dunque, di fronte a una “partita di giro” editoriale-finanziaria tra soggetti che condividono interessi di governance, e che in questa fase sembrano solo riorganizzare capitali all’interno della stessa filiera.
Nel momento in cui Meta viene obbligata a pagare, il gruppo beneficiario è quello più integrato nelle logiche della piattaforma stessa. A sorprendere, però, è anche un altro elemento: in una fase in cui Agcom, oggi sotto una guida politica di centrodestra, e AGCM, nel caso Ferragni e SIAE-Meta, mostrano un’inattesa incisività, si registra una maggiore fermezza istituzionale rispetto ad autorità in precedenza orientate a sinistra. Due casi emblematici – quello Ferragni e quello Gedi–Meta – dimostrano che la regolazione dei rapporti con le big tech richiede non solo strumenti normativi, ma soprattutto indipendenza culturale, finora assente.
C’è da chiedersi se questa sia una svolta reale per il giornalismo italiano o se siamo solo dinanzi a un atto finale di una lunga farsa in cui, a forza di chiedere briciole di visibilità, il settore ha barattato libertà d’informazione in cambio di sponsorizzazioni. Il paradosso resta: gli stessi che oggi celebrano Gedi per aver ottenuto 10 milioni di euro, sono gli stessi che ieri difendevano l’inviolabilità decisionale delle piattaforme private, proclamando che potessero fare ciò che volevano.
Ma se un’azienda straniera limita il diritto all’informazione e la libertà di pensiero in un paese sovrano, quello che si configura non è semplicemente una scelta editoriale, bensì una forma di ingerenza straniera, aggravata dal fatto che a sostenerla sono stati in questi anni editori, Giornalisti e figure opache spacciate per professionisti compiacenti, figure che Matrice Digitale ha definito “meta-accattoni”, premiati da visibilità in cambio della normalizzazione del dissenso.
La lotta per un’informazione libera non può prescindere da una netta opposizione a questi meccanismi opachi, che hanno di fatto inquinato il mercato, corrotto il giornalismo e travisato il ruolo costituzionale della stampa. Oggi più che mai serve trasparenza reale, non quella simulata dagli algoritmi, ma quella che consente ai cittadini di sapere chi decide cosa si può leggere, e perché.
Iscriviti alla Newsletter
Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.
Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.