L’inchiesta sul Garante della Privacy e sul dossier spedito in forma anonima, pubblicata in esclusiva da Matrice Digitale, ha suscitato ampio interesse tra i lettori. Molti avevano già ricevuto il documento via email o in altra forma, firmato con il nome del giurista Stefano Rodotà, considerato da molti il padre dell’istituzione italiana della privacy. L’attribuzione simbolica a Rodotà ha funzionato come detonatore simbolico, ma è opinione diffusa che si tratti di un documento redatto a più mani per tracciare una mappa critica dello stato attuale del collegio del Garante nonostante i primi sospetti fossero circoscritti a singoli elementi.
Le cautele editoriali e il ruolo di Matrice Digitale
Matrice Digitale ha scelto di non pubblicare l’intero contenuto del dossier, pur avendo avuto modo di verificarne alcuni punti attraverso fonti documentali pubbliche. La decisione è stata presa per tutelare i soggetti esterni all’Autorità citati nel documento e non coinvolti direttamente nella funzione pubblica. Tuttavia, la sola esistenza del dossier è stata ritenuta dalla redazione una notizia degna di pubblicazione, soprattutto a fronte del silenzio con cui è stata accolta da gran parte del sistema informativo nazionale seppur ci siano indiscrezioni di una certa attenzione in alcune testate giornalistiche dedite ancora al defunto giornalismo di inchiesta.
La polemica sul silenzio mediatico e i paladini della privacy
Il dossier, pur ignorato da molte redazioni, è circolato ampiamente tra addetti ai lavori e professionisti del settore privacy. In rete non sono mancate critiche a Matrice Digitale, accusata da alcuni di aver lanciato la notizia senza offrire accesso integrale al documento, ma la tutela dei soggetti coinvolti e non esposti pubblicamente resta il principio guida. Sorprende invece, e alimenta il sospetto, l’atteggiamento di chi si erge quotidianamente a difensore della privacy ma ha ignorato completamente la notizia.
Algoritmi e informazione: il vero tema sommerso
Il caso del dossier non riguarda soltanto l’operato del Garante, ma la gestione algoritmica dell’informazione digitale. Dopo la pubblicazione della Relazione annuale del Garante, avvenuta oltre due settimane prima dell’uscita del dossier, molte testate hanno ripreso frammenti del documento ufficiale con ritardo generando notizie a scoppio ritardato.
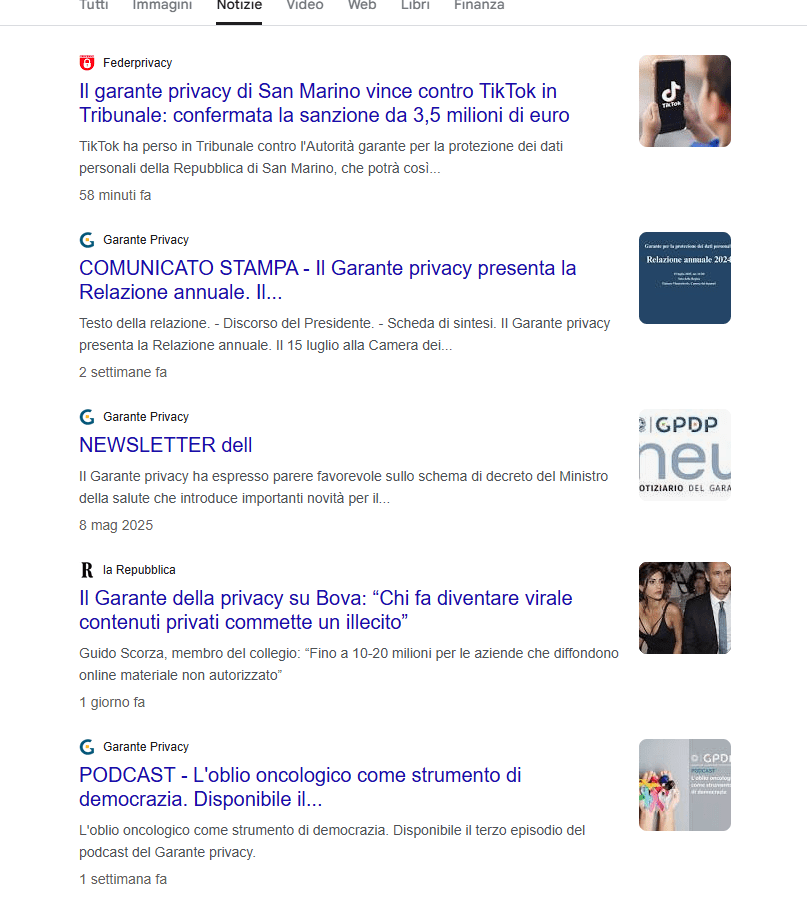
Una semplice ricerca su Google nella sezione notizie mostra l’assenza dell’articolo tra i risultati selezionati, mentre dominano notizie secondarie o neutre. Questo fenomeno riflette una dinamica nota: la selezione algoritmica favorisce fonti “allineate”, non necessariamente quelle più rilevanti o tempestive.
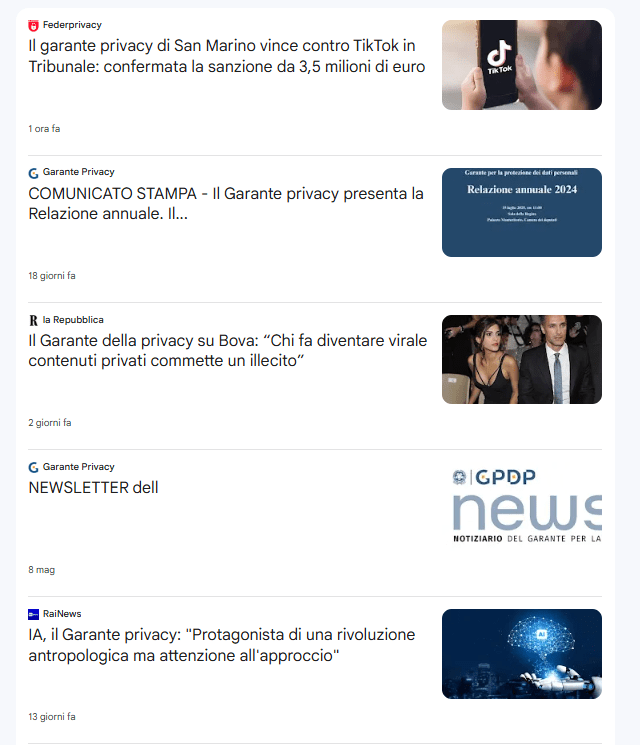
Per non parlare di Google News dove Matrice Digitale è una fonte accreditata, ma evidentemente l’algoritmo lì è monitorato da una manina come argomentato da tempo ed ha abilitato la notizia solo dell’iniziativa del Garante di individuare chi siano i presunti “diffamatori”. Oltre alla oramai obsoleta relazione annuale, proprio in questi giorni c’è una notizia che interessa gli italiani, interessati più a Temptation Island che alle questioni politiche, e riguarda l’attore Raul Bova.
Il ruolo dell’Autorità Garante
Il Garante oggi si muove in un equilibrio delicato tra posizionamento istituzionale e tensioni internazionali. Se da un lato mantiene un profilo formale protetto, dall’altro è coinvolto in uno scenario in cui le Autorità indipendenti sono percepite come strumenti strategici nei rapporti tra stati, Big Tech e apparati governativi. La posizione di chi presiede e compone il collegio, anche per via delle indennità importanti previste dal mandato settennale – 1.680.000 euro lordi per il Presidente e la stessa somma destinata al Collegio composto da tre membri – attira inevitabilmente pressioni, rivalità e tentativi di influenzare il ciclo di nomine.
Le origini del conflitto e l’ombra dei digital champions
Secondo fonti consultate da Matrice Digitale, il malcontento nei confronti degli attuali membri del collegio non è recente. Le tensioni risalirebbero addirittura al periodo dei cosiddetti Digital Champions, introdotti durante i governi Renzi e Gentiloni con l’obiettivo di creare una nuova classe dirigente esperta di tecnologie digitali. Quell’epoca, ormai dimenticata nell’archivio della rete, ha lasciato tracce profonde nelle dinamiche di potere tra tecnici, politici e professionisti del settore legale e IT. Secondo alcuni è stata un’occasione persa, per altri invece uno strumento di marketing spacciato per sociale avente il fine di favorire interessi particolari di uno stretto gruppo di esperti.
Una posizione ambita e una competenza indiscutibile
Al netto di queste tensioni, è innegabile che i membri del Collegio attuale siano figure competenti nel campo della protezione dei dati: dal Presidente agli altri componenti, salvo uno la cui nomina è puramente politica, sono presenti esperienze consolidate nella privacy e in alcuni casi attive da prima ancora che la disciplina venisse normata a livello europeo. Questo contraddice la narrativa del dossier come semplice azione di delegittimazione: la sua struttura articolata e i riferimenti specifici suonano piuttosto come un’operazione verità, seppur discussa e polarizzante.
Tra scontro istituzionale e strategia del silenzio
Il vero elemento preoccupante è il malumore crescente tra operatori, esperti e professionisti del settore, convinti che la politica premi appartenenze più che competenze. La questione non riguarda solo il Garante ma tocca l’intero sistema delle Autorità e la gestione della legittimità nei processi decisionali digitali e successivamente alla pubblicazione del Dossier, sono emerse due critiche allo strapotere giuridico dei Garanti attraverso gli addetti ai lavori Andrea Monti e Giuseppe Corasanti. Se il dossier è stato inviato da chi non ha ruoli pubblici ma denuncia un malessere strutturale, allora diventa urgente interrogarsi non solo sul contenuto ma sul contesto in cui questo tipo di iniziative si inseriscono.
Una questione di trasparenza e responsabilità
Contestare i contenuti anonimi può essere doveroso, ma ignorare l’esistenza del malcontento o del documento stesso appare come una forma di complicità passiva. La postura istituzionale non può più bastare: servirebbe un confronto aperto, trasparente e privo di tabù anche all’interno delle Istituzioni che, per missione, dovrebbero garantire i diritti fondamentali in un’epoca di sorveglianza pervasiva e di verità algoritmiche. C’è però anche un altro quesito d’obbligo e riguarda gli autori del libello e la sua diffusione in forma anonima:
è stato scritto per diffondere la verità sull’assenza di una postura istituzionale dei componenti dell’Organo di Garanzia dei Dati Personali oppure perché sono validi professionisti che sono riusciti ad ottenere un incarico ambito da molti?
Iscriviti alla Newsletter
Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.
Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.









