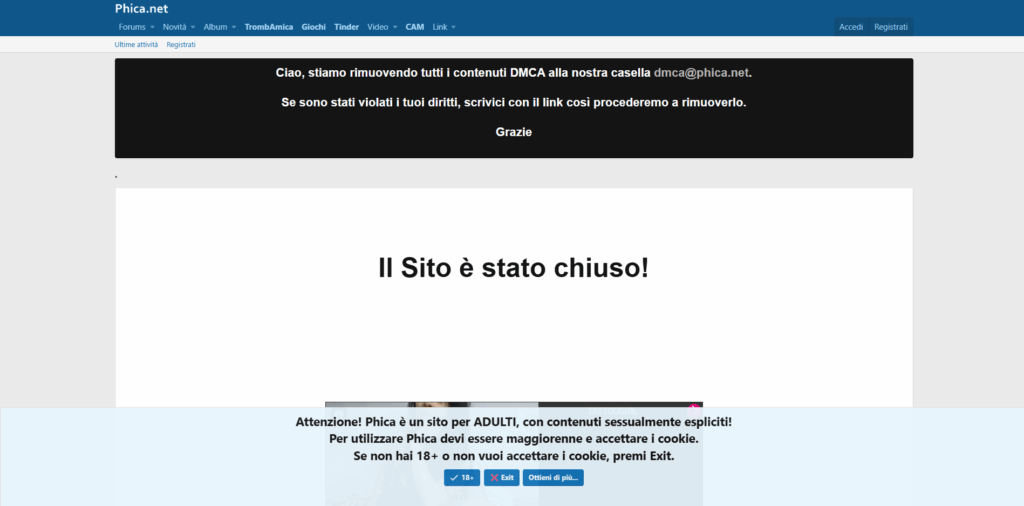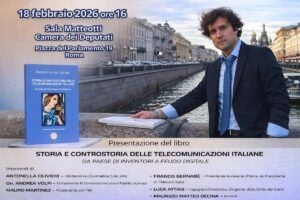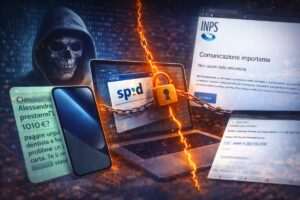La chiusura di Phica, annunciata improvvisamente dopo quasi vent’anni di attività, rappresenta uno degli episodi più gravi e simbolici della lunga battaglia contro la violenza digitale in Italia. Nato nel 2005 come spazio per contenuti amatoriali, il sito si è progressivamente trasformato in un forum tossico, dove migliaia di utenti hanno condiviso foto rubate e accompagnate da insulti sessisti, alimentando un sistema organizzato di denigrazione e umiliazione soprattutto contro le donne. L’epilogo è arrivato solo dopo anni di denunce ignorate, campagne mediatiche e pressioni sociali che hanno reso impossibile la sopravvivenza di una piattaforma ormai fuori controllo.
La degenerazione di Phica da forum amatoriale a spazio misogino
Secondo le ricostruzioni, Phica.net era stato inizialmente concepito come punto di incontro per appassionati di contenuti amatoriali. Con il passare del tempo, tuttavia, si è trasformato in un luogo dove gli utenti hanno iniziato a caricare immagini private senza consenso, spesso sottratte dai social network o tramite accessi non autorizzati ad account personali. Le sezioni del forum, dedicate anche a politiche, giornaliste e celebrità, ospitavano contenuti modificati con fotomontaggi e deepfake, insieme a commenti sessisti e minacce di violenza. Le vittime non erano solo donne comuni, ma anche figure pubbliche di rilievo come Giorgia Meloni, Elly Schlein, Chiara Ferragni, Paola e Chiara, Carla Bruni e Chanel Totti, tutte finite al centro di discussioni degradanti. Le umiliazioni digitali si sono tradotte in conseguenze psicologiche pesanti, con casi di ansia, depressione e minacce dirette, in un contesto dove la vergogna pubblica veniva amplificata dalla viralità della rete.
Denunce ignorate e inerzia istituzionale
Già nel 2019 la sociologa Silvia Semenzin, insieme a Lucia Bainotti, aveva denunciato pubblicamente l’esistenza di sezioni dedicate al revenge porn su Phica, portando il caso all’attenzione della Polizia Postale. Nonostante la gravità delle segnalazioni e l’entrata in vigore del Codice Rosso, le autorità non avevano adottato misure decisive. La questione era stata archiviata troppo in fretta, evidenziando l’assenza di un approccio sistemico al problema della violenza digitale. Le istituzioni hanno cominciato a reagire solo di fronte a una crescente pressione mediatica, con petizioni firmate da centinaia di migliaia di cittadini e appelli lanciati da associazioni e vittime. L’inerzia politica e giudiziaria ha permesso al sito di prosperare per anni, fino a quando la reputazione pubblica e le denunce di massa hanno costretto gli amministratori a dichiararne la chiusura.
La decisione degli amministratori e le indagini
Gli amministratori di Phica, attraverso un comunicato, hanno ammesso di non essere riusciti a fermare le violazioni, giustificando la chiusura con l’impossibilità di contenere la deriva della piattaforma. Pur rivendicando la collaborazione storica con le forze dell’ordine nella lotta alla pedopornografia, hanno riconosciuto il fallimento nel prevenire la diffusione di contenuti abusivi e minacce sessiste. La Polizia Postale ha già raccolto centinaia di denunce e avviato indagini per identificare gli utenti responsabili. Attraverso il tracciamento degli indirizzi IP e l’analisi dei server, le autorità puntano a risalire non solo agli autori delle condivisioni, ma anche ai commentatori che hanno alimentato il clima di odio. Le accuse vanno dalla diffamazione aggravata alla violazione dell’articolo 612 ter sul revenge porn, con pene fino a sette anni di carcere e multe per migliaia di euro. Gli utenti che hanno tentato di cancellare i propri account non potranno sfuggire: le tracce digitali rimangono nei log, rendendo possibile la ricostruzione delle attività illecite.
Le testimonianze delle vittime e l’impatto psicologico
La chiusura di Phica è stata accompagnata da una serie di testimonianze pubbliche. Politiche come Lia Quartapelle, Alessia Morani, Alessandra Moretti e giornaliste della RAI come Laura Chimenti, Maria Soave e Valentina Bisti hanno raccontato pubblicamente le esperienze di umiliazione, l’angoscia quotidiana e le minacce ricevute. Artiste e cantanti, come Martina Attili e Valentina Parisse, hanno rivelato come le immagini rubate abbiano compromesso la loro vita personale e professionale. Le testimonianze non hanno soltanto messo in luce i danni individuali, ma hanno anche denunciato l’esistenza di un patriarcato digitale che normalizza l’abuso e riduce le donne a oggetti di derisione collettiva. Da qui è nata una mobilitazione che ha rafforzato la richiesta di azioni collettive, supporto legale e psicologico e un maggiore coinvolgimento delle istituzioni.
Limiti delle leggi sul revenge porn e necessità di riforme
Nonostante il Codice Rosso, le leggi italiane sul revenge porn si sono dimostrate insufficienti. Oggi, le norme puniscono la diffusione non consensuale di immagini intime, ma non coprono tutte le forme di abuso, in particolare i deepfake e gli attacchi organizzati di gruppo. La responsabilità di dimostrare l’intento di danno ricade sulle vittime, rendendo i procedimenti complessi e spesso inconcludenti. Inoltre, solo nel 20 percento dei casi si arriva a una condanna, con processi lunghi e logoranti. Gli esperti denunciano come la normativa non affronti i rischi derivanti dalle nuove tecnologie. L’uso dell’intelligenza artificiale per generare immagini false e l’aumento del 500 percento dei deepfake a contenuto sessuale hanno reso ancora più urgente un aggiornamento legislativo. A livello europeo, il Digital Services Act (DSA) introduce obblighi e sanzioni per le piattaforme, ma la sua applicazione resta disomogenea, e molti siti minori riescono a sfuggire ai controlli.
Strumenti di difesa e monitoraggio: il ruolo di pimeyes
Un dettaglio tecnico significativo riguarda l’uso di strumenti come PimEyes, un motore di ricerca basato su riconoscimento facciale che consente alle vittime di individuare la diffusione non autorizzata delle proprie immagini. Caricando una foto personale, l’algoritmo confronta i tratti del viso con miliardi di immagini online, restituendo link diretti alle fonti. Sebbene PimEyes rappresenti uno strumento utile per la tutela della privacy, la sua efficacia dipende dalla capacità delle vittime di agire rapidamente e dalla disponibilità delle autorità a rimuovere i contenuti attraverso procedure ufficiali. Le vittime sono inoltre incoraggiate a utilizzare sistemi di monitoraggio continuo, come Google Alert e ricerche mirate con operatori booleani, per prevenire ulteriori danni. Tuttavia, la responsabilità della difesa personale non può sostituire quella delle istituzioni e delle piattaforme tecnologiche, chiamate a garantire una protezione sistemica. Anche per tutelare i figli delle donne coinvolte.
Il consiglio di Paolo dal Checco
Un contributo utile alla discussione arriva anche dal consulente informatico forense Paolo Dal Checco, che su LinkedIn ha condiviso un consiglio pratico per aiutare le vittime a monitorare la propria presenza online. In un post ripreso da molti utenti, Dal Checco ha ricordato che, come testimoniato dall’attrice Chiara Becchimanzi, molte donne hanno scoperto solo per caso di essere finite su Phica.net. Per questo ha suggerito l’uso di un servizio gratuito, accessibile da questo link, che permette di creare alert simili a Google Alert ma più efficaci sui social network. Basta cliccare su “Crea” e poi su “Provalo ora” per inserire i termini da monitorare, come nome, cognome, indirizzo email o numero di telefono, separandoli con l’operatore booleano OR. Il sistema invia notifiche ogni volta che sul web o sui principali social network compaiono riferimenti ai dati inseriti. Come ha spiegato Dal Checco, chi ha nomi comuni potrà ricevere falsi positivi, ma è possibile raffinare le ricerche selezionando lingue specifiche o limitando il monitoraggio a blog, forum o piattaforme particolari. In questo modo, le persone possono avere un controllo più diretto sulla propria reputazione digitale e agire tempestivamente in caso di abusi.
Anche il CNU esprime preoccupazioni
Il Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) esprime forte preoccupazione per le segnalazioni relative alla diffusione, sul sito phica.eu e su altre piattaforme internazionali, di immagini di donne pubblicate senza consenso, tra le quali figurano anche rappresentanti delle Istituzioni. “Si tratta di pratiche che configurano una grave forma di revenge porn e di violenza digitale – afferma Sandra Cioffi, Presidente del CNU – che ledono la dignità e i diritti fondamentali delle persone coinvolte, spesso ignare della pubblicazione.” Il CNU – continua Cioffi – nell’ambito delle sue competenze istituzionali e da sempre impegnato su questo fronte, ricorda quanto mai importante sia l’attuazione effettiva del Digital Services Act (DSA), che impone alle piattaforme digitali obblighi stringenti di responsabilità e di rimozione rapida dei contenuti illeciti. È fondamentale che i meccanismi di segnalazione e rimozione previsti dal DSA diventino al più presto pienamente operativi ed efficaci. I dati diffusi da AGCOM lo scorso luglio confermano la gravità della situazione: almeno un italiano su due dichiara di essersi imbattuto online in contenuti di odio, disinformazione e revenge porn, mentre oltre l’80% della popolazione manifesta forte preoccupazione. Alla luce dell’aumento vertiginoso di questi reati, il CNU auspica una sempre più rapida applicazione delle norme, ricordando che la diffusione non consensuale di immagini intime è già punita dall’art. 612-ter del Codice penale. Il CNU riconosce che la problematica è complessa, poiché coinvolge anche piattaforme e siti con sede all’estero. Proprio per questo – conclude Cioffi – sottolinea la necessità di un confronto immediato e costante tra istituzioni, autorità competenti e società civile, per garantire la piena tutela dei diritti e della dignità delle donne vittime di violenza digitale, una piaga purtroppo in continua crescita e contro la quale il CNU ribadisce il proprio impegno.
Iscriviti alla Newsletter
Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.
Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.