La vicenda del Garante per la protezione dei dati personali esplosa con l’“ultima stagione” di Report non è una semplice querelle istituzionale, ma un intreccio di dossier fantasma, studi legali in prima fila, sentenze amministrative e un conflitto politico-mediatico che ha riaperto la questione della terzietà delle Autorità indipendenti. In questo scenario, il caso Telepass diventa un paradigma di come la protezione dei dati personali e la tutela della concorrenza si sovrappongano, ridefinendo gli equilibri tra potere pubblico, trasparenza e interessi privati.
Il nodo del dossier fantasma e la percezione della prossimità
Il “dossier fantasma”, con i suoi simbolismi visivi e i riferimenti incrociati tra E-Lex e il Garante Privacy, è diventato un catalizzatore di sospetti e narrazioni. Le immagini circolate online – loghi condivisi, eventi pubblici, foto simboliche – hanno generato la percezione di una prossimità non dichiarata tra l’Autorità e uno studio legale attivo in cause di grande rilievo economico. Il punto non è tanto la violazione formale, quanto il riflesso politico: quando la consulenza privata e la funzione pubblica si sfiorano, la fiducia rischia di evaporare. Da qui nasce la domanda cruciale:
chi garantisce che l’interesse tutelato sia quello dei cittadini e non dei clienti?
Una questione che il caso Telepass ha reso ancora più urgente, mostrando come privacy e antitrust non siano più sfere autonome ma orbite coincidenti in cui una decisione amministrativa può ribaltare un intero impianto sanzionatorio.
Il quadro politico e il cortocircuito della fiducia
Sul piano politico, la crisi è esplosa come una battaglia di legittimità. Giorgia Meloni ha respinto le accuse di interferenze sull’Autorità, ricordando che l’attuale composizione del Collegio risale a governi precedenti, con quote Pd e M5s e una presidenza in quota Pd. Elly Schlein ha invece denunciato una “crisi di trasparenza”, chiedendo l’azzeramento del Collegio per ripristinare fiducia e indipendenza. Il Movimento 5 Stelle ha parlato di favoritismi e spese opache, invocando le dimissioni immediate. Nel mezzo, Sigfrido Ranucci ha posto l’accento sulla “sensibilità politica” delle scelte dell’Autorità, mentre Peppe De Cristofaro ha chiesto un reset istituzionale evocando lo spirito di Stefano Rodotà, primo presidente del Garante. In questo scontro di visioni, la parola chiave resta fiducia: quando la fiducia vacilla, anche la percezione di indipendenza diventa un problema pubblico.
Telepass tra concorrenza e privacy: la lezione di una sentenza
Nel 2021, l’AGCM sanzionò Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.p.A. con una multa da 2 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli nella distribuzione di polizze Rc auto via app. La questione sembrava confinata alla trasparenza informativa e alla correttezza del marketing, ma la successiva sentenza del Consiglio di Stato ribaltò tutto: la sanzione venne annullata perché l’Antitrust non aveva coinvolto il Garante Privacy sui profili di trattamento dati. Il verdetto segnò un punto di svolta: la protezione dei dati non è un dettaglio tecnico, ma una variabile giuridica centrale anche nei procedimenti di mercato. Il messaggio ai regolatori è chiaro: nessuna decisione sulla concorrenza può ignorare l’impatto sui dati personali. Da allora, la lezione di Telepass è diventata riferimento per tutto il sistema: servono protocolli di cooperazione, consultazioni obbligatorie e istruttorie congiunte, per evitare che i cittadini restino schiacciati tra due autorità che parlano lingue diverse.
Il caso E-Lex e il dilemma della prossimità simbolica
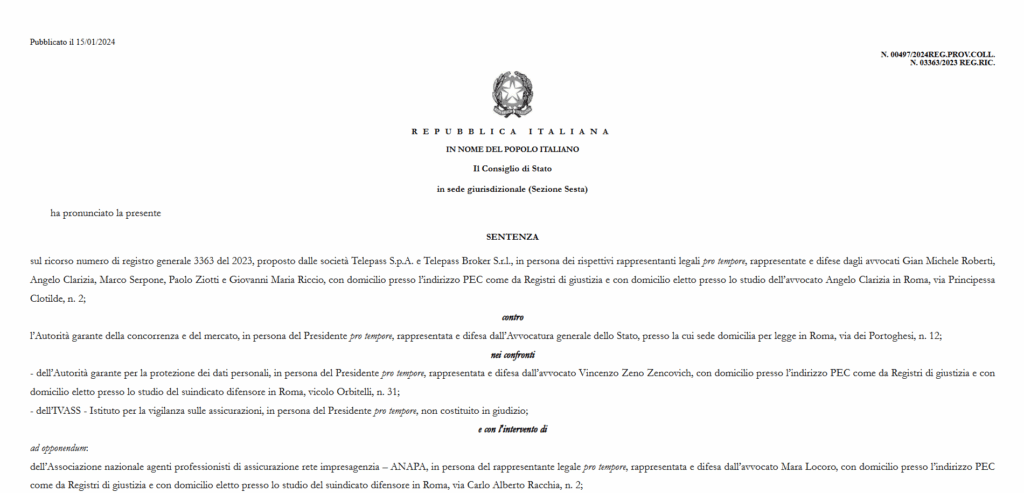
Il cuore del dibattito è il rapporto tra E-Lex, lo studio legale fondato nel 2011, e la figura di Giovanni Maria Riccio, oggi ordinario all’Università di Salerno (la stessa di Stanzione) ed ex socio del componente del Collegio del Garante, Guido Scorza, che si è occupato della difesa dell’azienda Telepass.
Le immagini e i post che associano il logo dell’Autorità a eventi o iniziative in cui figurano professionisti di E-Lex hanno alimentato un clima di sospetto tra gli addetti ai lavori finanche tra le gole profonde interne al Garante. Riccio ha respinto ogni illazione, chiarendo che non esistono rapporti professionali con Pasquale Stanzione, che E-Lex precede la sua nomina nel Collegio, e che le cifre citate in alcuni articoli sono inesatte e diffamatorie. Tuttavia, il problema resta di percezione: in un’epoca di comunicazione visiva, anche la semplice prossimità simbolica può generare dubbi sulla neutralità delle decisioni. La domanda resta aperta:
E-Lex ha anticipato con un’intuizione giuridica il coordinamento AGCM-Garante, o ha goduto di un vantaggio percettivo che ha influito, indirettamente, sugli equilibri tra Autorità?
La risposta può arrivare solo con trasparenza documentale: regole di ricusazione pubbliche, registri delle interlocuzioni e tracciabilità dei pareri inter-autorità.
Il protocollo AGCM-Garante e la nuova architettura della cooperazione
A luglio 2025, AGCM e Garante Privacy hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare la cooperazione. L’accordo prevede segnalazioni reciproche, tavoli tecnici permanenti, scambi informativi, istruttorie coordinate e persino indagini congiunte. È un passo avanti, ma non basta. Il protocollo è la cornice operativa: ciò che manca è una procedura trasparente e prevedibile. Serve una checklist pubblica che definisca quando il Garante deve essere coinvolto, come si documentano i pareri e come si gestiscono i conflitti d’interesse. Solo così la cooperazione diventa governance effettiva, non un esercizio burocratico.
Iscriviti alla Newsletter
Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.
Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.









