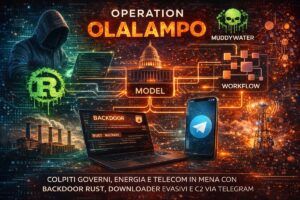Oltre il 95% del traffico globale di Internet transita attraverso cavi sottomarini in fibra ottica, nascosti sotto i fondali oceanici. Queste infrastrutture rappresentano la vera spina dorsale della comunicazione digitale mondiale, trasportando dati sensibili come messaggi, transazioni bancarie, chiamate video, dati satellitari e persino comunicazioni militari. Chi controlla questi cavi detiene un potere reale sul flusso delle informazioni a livello planetario, influenzando accessibilità, sicurezza e sovranità dei dati.
La nuova corsa ai cavi sottomarini
Per decenni la posa e la gestione dei cavi sottomarini erano prerogativa di consorzi di telecomunicazioni e governi. Il quadro è cambiato radicalmente con l’ingresso delle Big Tech come Google, Meta, Amazon e Microsoft, che oggi finanziano e gestiscono direttamente nuove infrastrutture. Google, ad esempio, conta più di venti sistemi sottomarini attivi, tra cui Equiano, dal Portogallo al Sudafrica. Questa transizione permette alle piattaforme di controllare le rotte dei dati, stabilire i costi e condizionare chi può accedere o meno alla rete.
Il dominio tecnologico si intreccia al rischio geopolitico
La competizione tra aziende tecnologiche e Stati assume connotati geopolitici sempre più marcati. Governi e alleanze, come gli Stati Uniti e i loro partner, hanno iniziato a escludere aziende cinesi da progetti strategici per il timore di spionaggio. La Cina risponde investendo in sistemi paralleli, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle rotte occidentali. Le tensioni sfociano spesso in incidenti sospetti: nel 2024 interruzioni anomale nel Mar Rosso hanno sollevato il sospetto di sabotaggi deliberati. I cavi diventano così non solo infrastrutture tecnologiche, ma bersagli strategici in caso di conflitti o crisi diplomatiche.
L’impatto sulla sovranità digitale e sulle economie locali
Per molti Paesi in via di sviluppo, come quelli africani, la presenza delle Big Tech rappresenta un’opportunità di crescita, garantendo connessioni più veloci e abbattendo i costi. Tuttavia, questa dipendenza rischia di tradursi in una vulnerabilità: chi possiede la rete può modificare unilateralmente le condizioni di accesso o bloccare il servizio in caso di dispute politiche o tecniche. Il controllo della connettività da parte di pochi attori globali limita l’autonomia delle nazioni e amplifica i rischi in caso di disservizi o attacchi mirati.
La corsa normativa e la fragilità delle leggi storiche in Europa
I recenti sabotaggi ai cavi sottomarini nel Mar Baltico e nel Mar del Nord hanno esposto le debolezze delle legislazioni nazionali, spesso ancorate a normative obsolete. Nel Regno Unito, la Submarine Telegraph Act del 1885 prevedeva solo una sanzione di 1.000 sterline, oggi chiaramente inadeguata. Il governo britannico ha riconosciuto la necessità di nuove leggi per affrontare minacce ibride e “gray zone”, ovvero azioni ostili che non raggiungono formalmente il livello di conflitto armato ma possono compromettere la sicurezza strategica del Paese.
Le autorità britanniche hanno avviato una revisione strategica per varare un Defence Readiness Bill, aggiornando i protocolli di risposta anche nell’ambito della riserva militare. Le sanzioni pecuniarie verranno probabilmente aumentate, ma il dibattito politico si concentra sulla definizione di strumenti più incisivi per distinguere tra tempo di pace, crisi e guerra, colmando le lacune normative che espongono la rete sottomarina a rischi senza precedenti.
Minacce emergenti: sabotaggi e operazioni sotto falsa bandiera
Negli ultimi anni, analisi come quella del China Strategic Risks Institute hanno documentato almeno dodici episodi di sabotaggio sospetto, con navi identificate e spesso legate a compagnie o bandiere russe e cinesi. Il danneggiamento di cavi strategici tra Svezia e Lettonia, nonché i guasti agli interconnettori tra Finlandia ed Estonia, sono solo alcuni degli esempi che dimostrano come la guerra invisibile sui cavi sia una realtà in espansione. La difficoltà di attribuire formalmente la responsabilità di questi atti complica ulteriormente le contromisure, alimentando il clima di incertezza e la corsa alle contromisure tecnologiche e legali.
Sovranità digitale, sicurezza nazionale e futuro delle infrastrutture globali
La sicurezza delle infrastrutture critiche dipende oggi da un delicato equilibrio tra iniziativa privata, regolamentazione pubblica e cooperazione internazionale. Il predominio delle Big Tech rischia di concentrare potere e vulnerabilità, mentre le potenze globali sono impegnate in una guerra silenziosa fatta di sabotaggi, esclusioni commerciali e progetti infrastrutturali paralleli. Le sfide del futuro ruotano attorno alla resilienza delle reti, alla capacità di prevenire incidenti e sabotaggi e al ripensamento delle leggi per fronteggiare minacce che non sono più solo virtuali, ma profondamente radicate nella realtà materiale dell’infrastruttura digitale.
Regno Unito rivede le leggi per la sicurezza delle infrastrutture digitali
I recenti episodi di cyberattacchi e sabotaggi ai cavi sottomarini hanno evidenziato la fragilità delle normative vigenti nel Regno Unito, sollevando un urgente dibattito sulla necessità di aggiornare il quadro legislativo per rispondere a minacce ibride tra pace e conflitto. La Submarine Telegraph Act del 1885, che prevede multe fino a 1.000 sterline, appare oggi del tutto insufficiente di fronte ai rischi moderni. Il governo britannico, con la recente Strategic Defence Review, propone l’adozione di un Defence Readiness Bill per coprire il fenomeno degli attacchi informatici sponsorizzati da Stati e dei sabotaggi fisici alle reti di comunicazione.
Ambiguità giuridiche e rischio di escalation nella zona grigia
Le audizioni parlamentari hanno messo in luce la complessità nel distinguere tra atti di guerra e “gray zone threats”, cioè attività ostili sotto la soglia del conflitto armato. Episodi come il sospetto sabotaggio di un cavo tra Svezia e Lettonia, o i guasti alle linee tra Finlandia ed Estonia, mostrano che la transizione tra pace e crisi non è coperta da strumenti giuridici adeguati. L’assenza di una definizione chiara del momento in cui un attacco a un’infrastruttura critica diventa casus belli complica la risposta, sia sul piano nazionale che nell’ambito di alleanze come la NATO.
Collaborazione interministeriale e necessità di nuove sanzioni
Il Ministero della Difesa e il Department for Science, Innovation and Technology stanno lavorando congiuntamente per proporre una normativa aggiornata che possa superare le semplici sanzioni pecuniarie, ritenute inadeguate. Il nuovo impianto legislativo dovrà affrontare la gestione della riserva militare e la preparazione delle forze in caso di crisi, colmando il vuoto tra gli attuali scenari di pace e l’eventuale conflitto aperto.
Minacce crescenti da Russia e Cina: dati e analisi dei sabotaggi
Un’analisi condotta dal China Strategic Risks Institute ha identificato dodici episodi di sabotaggio sospetto ai cavi tra il 2021 e il 2025, con la maggior parte delle navi coinvolte riconducibili a interessi russi o cinesi. Questi eventi sottolineano l’incremento delle operazioni ostili nel contesto delle tensioni globali, mentre il Regno Unito e l’Europa appaiono ancora impreparati rispetto alla crescente sofisticazione delle minacce.
Resilienza e protezione delle reti critiche
La protezione delle infrastrutture sottomarine richiede una revisione profonda delle strategie difensive, con soluzioni che integrino sorveglianza avanzata, monitoraggio in tempo reale delle anomalie e cooperazione internazionale. L’adozione di nuove tecnologie per il tracciamento dei tentativi di sabotaggio, l’innalzamento delle sanzioni e la definizione di regole d’ingaggio chiare sono elementi chiave per garantire la sicurezza della dorsale digitale europea e internazionale.
Iscriviti alla Newsletter
Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.
Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.