La nuova puntata di Report ha riacceso con forza i riflettori sul Garante Privacy, spazzando via la narrazione rassicurante di un’Autorità fatta solo di atti tecnici, pareri giuridici e distacco istituzionale. La fotografia che emerge è ben diversa: quattro figure di altissimo profilo, tra accademici, avvocati e un politico con decenni di carriera alle spalle, finite in scacco matto di fronte alla rivelazione di una richiesta interna simbolicamente devastante. Il segretario generale dell’Autorità, da poco dimesso, ha chiesto di estrapolare su DVD i dati e le e-mail di tutti i dipendenti dal 2000 ad oggi, facendo esplodere una vera e propria vergogna istituzionale proprio dentro la casa che, per anni, ha imposto al Paese regole rigidissime in tema di controlli, log e monitoraggio dei lavoratori. Una situazione che mette in crisi non solo l’attuale Collegio, ma l’intera idea di autorità indipendente su cui si regge l’architettura della protezione dei dati in Italia. Di fronte a questo scenario, la retorica dei “nostalgici del Garante che parla solo con gli atti” appare improvvisamente fuori tempo. La vicenda delle mail, la reazione interna, la resistenza alle dimissioni e l’arrivo di un nuovo direttore generale, Luigi Montuori, mostrano un ente attraversato da tensioni profonde, dove la tutela dei diritti fondamentali convive con ambizioni personali, carriere prestigiose e stipendi da vertice assoluto della pubblica amministrazione.
Cosa leggere
Un collegio di giuristi eccellenti travolto da una richiesta insostenibile
Per anni, l’immagine pubblica del Garante Privacy è stata quella di un fortino tecnico-giuridico: due accademici stimati, un avvocato molto noto, un politico navigato con quarant’anni di esperienza, chiamati a bilanciare diritti fondamentali, poteri di vigilanza e sanzioni milionarie. Un equilibrio delicato, fondato sul presupposto che chi siede in quelle stanze sia al di sopra del sospetto, almeno quanto lo si pretende da imprese e pubbliche amministrazioni. La puntata di Report del 23 novembre spezza questa rappresentazione e la rovescia. Al centro, c’è la richiesta del segretario generale dell’Autorità di acquisire, in forma di DVD, l’intero patrimonio di e-mail e dati interni dei dipendenti dal 2000 ad oggi. Non un controllo puntuale, non un intervento mirato su un singolo account sospetto, ma un’operazione che appare, agli occhi dei lavoratori e dell’opinione pubblica, come un tentativo di spionaggio interno sistematico, finalizzato a risalire a chi ha parlato con la stampa e con i giornalisti d’inchiesta. È qui che la vergogna istituzionale diventa evidente. L’Autorità che ha costruito la propria reputazione richiamando aziende e PA al rispetto delle norme sui log, sui controlli a distanza, sulla conservazione dei dati, si ritrova sotto accusa per aver progettato, al proprio interno, un’operazione che contraddice in pieno quella cultura di legalità digitale. Non è solo un errore tecnico o formale: è un cortocircuito simbolico che colpisce al cuore la credibilità del garante.
La vergogna istituzionale e lo scaricabarile tra politica e governance
La reazione istintiva del Collegio è stata quella di scaricare la responsabilità sul livello gestionale, facendo intendere che la richiesta sarebbe farina del sacco del segretario generale, figura “tecnica” appena arrivata e non pienamente allineata alla sensibilità giuridica dell’ente. Una linea difensiva che lascia però molti punti interrogativi. Perché, come ricordano in molti, non si è trattato di una svista marginale. Una simile richiesta, che punta a congelare decenni di corrispondenza e log, non può che essere letta come la manifestazione di una cultura organizzativa distorta, in cui la priorità non è la tutela dei diritti dei lavoratori, ma la ricerca del “colpevole” che ha osato parlare all’esterno. Questo scaricabarile tra ala politica e ala di governance non ha convinto né i dipendenti né chi osserva da fuori che grazie a Report ha avuto modo di ascoltare alcuni passi nel confronto avvenuto nell’ultima riunione sindacale tra Collegio, Direzione Generale ed i lavoratori. Chi difende il Collegio insiste sulla distinzione tra responsabilità politica di indirizzo e responsabilità gestionale, ma la sostanza è che, agli occhi del Paese, l’Autorità nel suo complesso esce da questa vicenda come un soggetto che predica rigore e pratica ambiguità.
Il mito del Garante che parla solo con gli atti e la claque su LinkedIn
La crisi attuale smonta anche l’immagine idealizzata di un Garante che “parla solo con gli atti”, distante dai talk show, dalle polemiche e dalle dinamiche di consenso. In realtà, attorno all’Autorità si è negli anni costruita una rete molto fitta di conferenze, interventi pubblici, presenze sui social, in particolare su LinkedIn, dove ruota una vera e propria claque di conferenzieri di professione, consulenti, amici e alleati. In questo ecosistema, il Collegio ha trovato spesso sponde favorevoli e platee amiche, pronte ad applaudire ogni presa di posizione come se fosse automaticamente sinonimo di rigore e innovazione. Ma l’eco di questo microcosmo digitale stride violentemente con ciò che è emerso dagli ultimi servizi televisivi e dalle inchieste giornalistiche. Fuori da LinkedIn, il racconto è un altro: rapporti sbilanciati con grandi piattaforme, decisioni controverse, casi in cui la linea del garante sembra essersi adattata più ai contesti politici e alle pressioni esterne che alla lettura pura e semplice delle norme. La puntata di Report, nel riportare questi elementi in prima serata, ha incrinato irreversibilmente la narrazione glamour di un garante “cool” e iper-competente, amato dai panel e dagli eventi, ma molto meno convincente quando deve rispondere su scelte concrete.
Resistenza alle dimissioni e la linea del “far passare la tempesta”
All’indomani della puntata, molti si sarebbero aspettati un gesto politico forte, a partire dalle dimissioni del Collegio. Non è accaduto. La linea prevalente è stata quella di resistere, provare a “far passare l’aria turbolenta”, confidando che l’attenzione mediatica si sposti altrove e che l’Autorità possa continuare a lavorare senza strappi. Questa strategia era stata già intuita quando, dopo le prime inchieste, uno dei componenti del Collegio aveva ostentato in pubblico la propria sicurezza sul proprio operato e su quello dei colleghi, invitando a non drammatizzare e a guardare ai risultati di questi anni. Ma la richiesta di estrazione massiva di dati interni ha segnato un punto di non ritorno, trasformando una controversia politico-mediatica in un problema di tenuta etica e giuridica dell’Ente. Oggi, l’eventuale uscita di scena del Collegio non dipende più da un moto di coscienza interna, ma dall’esito di tre esposti ormai presentati in diverse sedi: dalla Corte dei conti alle procure ordinarie. Sarà la magistratura, eventualmente, a sancire se la linea di difesa regge o se, al contrario, sono state travalicate soglie che richiedono un cambio di guida. Nel frattempo, il messaggio che arriva ai cittadini è quello di un Garante che preferisce restare aggrappato al proprio incarico, nonostante una frattura profonda con la propria base interna.
Gli esposti e il ruolo determinante della Magistratura
Il fatto che oggi si contino già tre esposti contro l’operato del garante non è un dettaglio. È il segnale di una sfiducia che non è più confinata alle opposizioni politiche o a una singola testata, ma che ha preso la forma di atti formali, destinati a essere esaminati da giudici contabili e giudici ordinari. Se questi esposti dovessero tradursi in indagini approfondite o in contestazioni puntuali, l’Autorità potrebbe trovarsi per la prima volta sotto una lente che non è più solo mediatica, ma giurisdizionale. In quel caso, la narrazione dell’indipendenza potrebbe non bastare più a giustificare l’inerzia. Il paradosso è evidente: un organo nato per vigilare sul rispetto delle regole e per sanzionare gli altri, si ritrova a dover giustificare proprio quei comportamenti che, in altre circostanze, avrebbe censurato. Se il garante ha passato anni a ricordare alle aziende che, al primo odore di controllo occulto sulle e-mail dei dipendenti, scattano sanzioni e provvedimenti, è inevitabile che oggi la domanda del Paese sia: chi vigila sul Garante?
Luigi Montuori, il nuovo direttore interno e una macchina amministrativa sfiduciata
In questo clima, uno degli snodi più delicati è la nomina di Luigi Montuori a nuovo direttore generale. La sua figura viene presentata come la scelta di un interno con lunga esperienza nella pubblica amministrazione, una sorta di evoluzione naturale di una carriera costruita dentro l’Autorità, lontano dagli intrecci più evidenti tra politica, studi legali e circuiti di potere. Per molti, Montuori rappresenta la possibilità di ricucire il rapporto con la macchina amministrativa, profondamente scossa da quanto emerso. Una figura che potrebbe ridare centralità alle competenze tecniche e alla cultura del servizio pubblico, anziché a logiche di visibilità personale e posizionamento sui social. Ma nessun direttore, per quanto stimato, può da solo cancellare la sfiducia accumulata. I dipendenti hanno visto con i propri occhi quanto sia stato facile immaginare un’operazione di acquisizione integrale di mail e log, e hanno assistito alla resistenza compatta del Collegio di fronte alla richiesta di dimissioni trovando in Fanizza l’unico responsabile dell’ignobile quanto illegale gesto. La scelta di Montuori può essere un segnale, ma non sostituisce la necessità di una assunzione chiara di responsabilità politica e istituzionale da parte dei vertici.
Conferenze, visibilità social e grazie distribuite a cerchie ristrette
Non si risparmia neppure il tema delle relazioni esterne del Garante della Privacy. Negli ultimi anni, l’Autorità è stata spesso al centro di convegni, festival, eventi patrocinati, dove alcuni professionisti hanno accumulato una visibilità evidente, mentre altri restavano ai margini. La critica che emerge è quella di un sistema in cui forme di “grazia” e riconoscimento pubblico sembrano distribuite in modo selettivo, alimentando la percezione che alcuni professionisti, tra cui influencer e giornalisti, siano più vicini al Collegio di altri. Per un’Autorità che dovrebbe essere baluardo di imparzialità, anche questa dimensione comunicativa diventa un elemento di rischio reputazionale. Report, dando voce a queste dinamiche e mostrando quanto fossero già attenzionate da tempo prima che esplodesse il caso mediatico, ha messo a nudo il contrasto tra una retorica ufficiale fatta di formalismi e atti e una pratica quotidiana che appare molto più umana, relazionale, perfino clientelare. In questo divario si gioca gran parte della crisi di credibilità attuale.
Dimissioni, istituzioni e il coraggio che in Italia manca
Uno dei passaggi più forti del ragionamento è il confronto con la cultura delle dimissioni in Italia. In teoria, le dimissioni servono a proteggere le istituzioni, non a indebolirle. Sono lo strumento attraverso cui si riconosce che la credibilità di un ente vale più del destino individuale delle persone che lo guidano. Eppure, si osserva amaramente, l’Italia è un Paese in cui le dimissioni arrivano quasi sempre da parte di persone coraggiose o di chi non vive di politica, mentre chi ha legato la propria identità a un ruolo pubblico tende a restare, qualunque cosa accada.
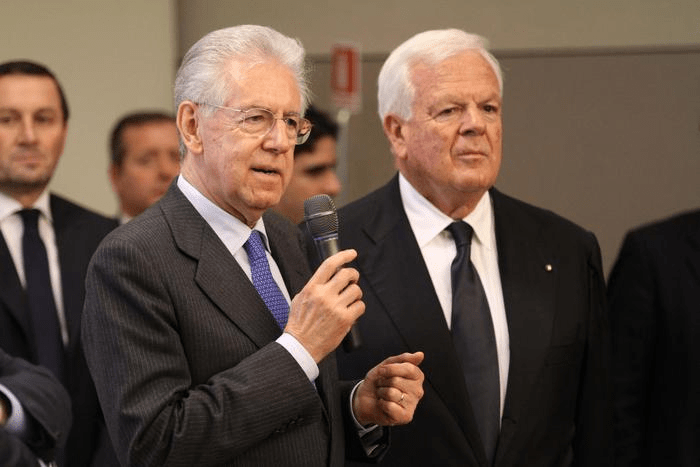
Il richiamo al caso del cavaliere Cimmino, patron di un grande gruppo industriale, che decise di lasciare il Parlamento dopo la caduta del progetto politico di Mario Monti per non contaminare con la politica la storia e la tradizione della propria azienda, è emblematico. Lì, la dimensione economica e industriale non è stata usata come scudo per restare, ma come motivo per fare un passo indietro. Nel caso del Garante della Privacy, invece, la sensazione è opposta: che il peso simbolico del ruolo venga usato per giustificare la permanenza, anche in presenza di una tempesta senza precedenti.
Il nodo degli stipendi d’oro e del “sogno” da 240 mila euro l’anno
C’è poi un tema meno dichiarato, ma centrale: quello economico. Il posto nel Collegio del Garante della Privacy è, per molti giuristi, il sogno di una vita. Non solo per il prestigio, ma anche per un trattamento economico che si colloca tra i più alti della pubblica amministrazione, attorno ai 240 mila euro l’anno. Lasciare una posizione così significa rinunciare a uno status, una rendita, una vetrina difficilmente replicabili altrove. Certo, è plausibile che le figure oggi sedute nel Collegio potrebbero tornare a guadagnare molto anche nel settore privato o accademico. Ma non con la stessa combinazione di potere regolatorio, visibilità pubblica e sicurezza istituzionale che un’autorità indipendente garantisce. È qui che la vicenda assume un tono quasi amaro. L’idea di un Garante povero ma libero, che sacrifica tempo e guadagni per servire il Paese, lascia il posto alla percezione di un ruolo che, nella pratica, può trasformarsi in una sintesi di divulgatore mediatico, sanzionatore pubblico e quasi-giudice, con la possibilità di emettere decisioni dal peso enorme senza appartenere formalmente alla magistratura.
Quando la crisi di fiducia supera le strategie di comunicazione
Alla fine, il nodo è uno solo: la fiducia. La fiducia dei cittadini che affidano al garante i propri dati e i propri diritti. La fiducia dei dipendenti che hanno visto mettere per iscritto un ordine che puntava alle loro e-mail e ai loro log di accesso. La fiducia degli operatori del settore che guardano al garante come punto di riferimento, non come soggetto da “gestire” o aggirare. Nessuna strategia di comunicazione, nessun post rassicurante, nessuna conferenza di alto profilo può colmare il vuoto che si apre quando un’Autorità di garanzia appare incapace di applicare a se stessa i principi che impone agli altri. Se la stagione aperta da Report porterà a un cambio di passo reale o si limiterà a qualche aggiustamento cosmetico lo dirà il tempo, e forse lo diranno i giudici. Di certo, però, una fase si è chiusa: quella in cui bastava evocare l’indipendenza formale e la qualità dei curricula per mettere a tacere ogni critica. Oggi l’Autorità dovrà dimostrare, con fatti concreti e scelte dolorose, di essere all’altezza del compito di garantire la privacy degli italiani, invece di difendere se stessa da ciò che emerge quando i riflettori si accendono davvero.

