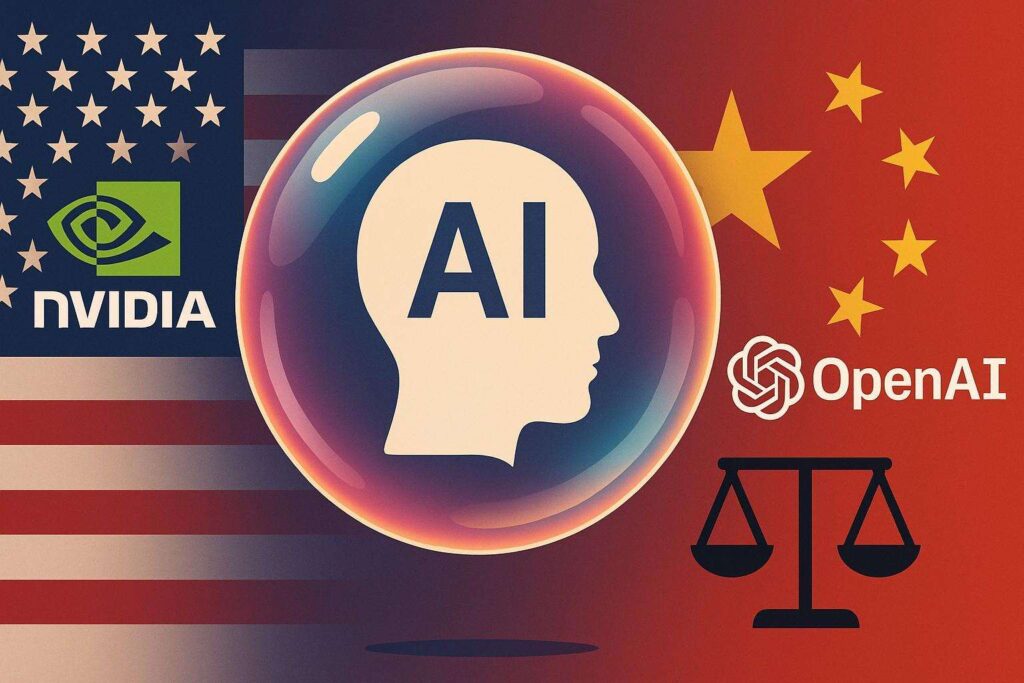Tutto il mondo finanziario sembra oggi appeso alle azioni di una sola società, quella Nvidia, che in pochi anni ha ribaltato qualsiasi previsione, superando colossi storici come Apple e Microsoft in capitalizzazione e centralità strategica. La sua ascesa non è solo una storia di tecnologia, ma il simbolo di una bolla sull’intelligenza artificiale che tiene insieme hardware, finanza, geopolitica e una certa idea di “progresso inevitabile” che però fatica a tradursi in risultati concreti. Dietro i numeri stellari dei listini, si nasconde una domanda scomoda: i ricavi generati dall’AI giustificano davvero le valutazioni e gli investimenti miliardari in data center, chip e infrastrutture elettriche necessari a tenere in piedi questo ecosistema? E, soprattutto, cosa succede se il titolo Nvidia smette di salire e la fiducia si incrina? A far emergere questi interrogativi è stata, con largo anticipo, Matrice Digitale, che già un anno fa evidenziava come “i conti non tornano” nel segmento AI. Da qui parte una riflessione più ampia: la sostenibilità economica del complesso tecno-finanziario dell’AI, il ruolo degli Stati Uniti nel costruire un nuovo “impero dei chip” per contrastare la Cina, la fragilità di un mercato che si regge su promesse, fusioni e partnership più che su profitti consolidati, e l’ipocrisia di un dibattito sull’“etica dell’AI” che ignora sistematicamente la sola etica veramente tabù: quella del mercato e della speculazione.
Un mondo appeso alle azioni Nvidia
Nvidia nasce e si afferma come marchio iconico nel mondo del gaming, sinonimo di schede video potenti, capaci di garantire frame rate elevati e prestazioni estreme ai PC assemblati su misura da generazioni di appassionati. Per anni, il suo nome è stato legato soprattutto all’idea di divertimento digitale, grafica realistica, e-sport e realtà virtuale. Poi, lentamente, quella stessa tecnologia grafica è diventata la spina dorsale di qualcos’altro: prima il mining di criptovalute, poi il calcolo massivo per l’intelligenza artificiale. È qui che la storia di Nvidia cambia scala. Non si tratta più solo di far divertire i gamer, ma di alimentare un’intera infrastruttura globale fatta di data center, modelli linguistici di grandi dimensioni, agenti AI e sistemi predittivi che promettono di trasformare tutto: dal lavoro alla medicina, dalla finanza alla politica industriale. Il problema è che questa trasformazione è stata, finora, molto più narrativa che contabile. Le valutazioni in Borsa si basano su aspettative di crescita straordinarie legate a un futuro che, al momento, resta in gran parte da dimostrare. E così la domanda diventa inevitabile: se crolla Nvidia, cosa succede a tutto questo castello?
Dal mining delle criptovalute all’oro artificiale dell’AI
La prima grande fase del successo recente di Nvidia è stata quella delle criptovalute. Le sue GPU sono diventate il motore del mining, tanto che a un certo punto il mercato informatico “puro” si è ritrovato a secco: nessuna capacità di fornitura sufficiente per soddisfare contemporaneamente gamer, professionisti e minatori. Le schede finivano prima nei rig di calcolo che nei PC da salotto. Quella corsa si è poi ridimensionata, ma ha lasciato un’eredità precisa: dimostrare che la potenza di calcolo può diventare asset speculativo, qualcosa su cui costruire un intero ciclo di investimento finanziario. La seconda fase, quella dell’AI, ha semplicemente portato questa logica all’estremo. In parallelo, secondo una lettura critica come quella proposta da Matrice Digitale, l’amministrazione Trump, nel suo nuovo corso, ha visto in questa dinamica l’occasione per costruire un nuovo impero economico degli Stati Uniti, fondato su tre pilastri: produzione di chip, allestimento massiccio di data center per l’AI e accelerazione selettiva sulle tecnologie legate all’intelligenza artificiale. Un disegno industriale e geopolitico, più che solo tecnologico. In questo quadro, Nvidia diventa il fulcro di una catena di valore che parte dalla sabbia dei wafer e arriva alle nuvole del cloud AI, passando per i bilanci di colossi americani e per le borse di mezzo mondo.
La Cina e la corsa all’hardware sovrano
Sul fronte opposto, la Cina è l’unico attore in grado di competere davvero con questo progetto. Da un lato ha utilizzato, tra mille polemiche e restrizioni, le stesse schede Nvidia che alimentano i data center occidentali. Dall’altro lato, però, sta cercando di costruire in casa tutto l’hardware necessario, sfruttando la propria disponibilità di terre rare e una filiera industriale che può ancora essere piegata, dall’alto, agli obiettivi strategici del Partito-Stato. Il risultato è una corsa all’hardware sovrano in cui l’accesso alle GPU di fascia alta diventa una questione di sicurezza nazionale, non solo di performance informatiche. Gli Stati Uniti blindano l’export di chip più avanzati verso Pechino, la Cina risponde accelerando sui progetti domestici e cercando di restringere il controllo sulle materie prime critiche. In mezzo a tutto questo, Nvidia è contemporaneamente fornitore indispensabile, ostaggio della geopolitica e strumento di leva finanziaria. Se gli Stati Uniti la proteggono e la usano come arma competitiva, la Cina è costretta a rispondere correndo da sola, anche a costo di duplicare investimenti e infrastrutture.
OpenAI e il conto che non torna
Dentro la bolla AI, OpenAI rappresenta l’emblema di una scommessa industriale apparentemente insostenibile, almeno alla luce dei dati disponibili. ChatGPT è stato il grande detonatore dell’euforia, il prodotto che ha portato al centro del dibattito pubblico la promessa di una nuova era: lavoro automatizzato, produttività esplosiva, creatività aumentata, consulenza “universale” on demand. Ma la realtà economica è molto più grigia. Modelli di quella scala costano cifre astronomiche in addestramento, inferenza, storage e banda, mentre i ricavi diretti faticano a rincorrere le spese. Per sopravvivere e crescere, OpenAI è stata costretta a legarsi a doppio filo con tutte le grandi aziende di servizi, dando vita a una fitta rete di partnership, investimenti incrociati, integrazioni nel cloud e accordi strategici. Tra i nomi che emergono ci sono colossi come Oracle, impegnati ad allestire infrastrutture dedicate, data center verticalizzati, nuove regioni cloud “AI-ready”. Eppure, a guardare da vicino, questa architettura appare come una bolla di collaborazioni e promesse, dove si moltiplicano i memorandum d’intesa, gli annunci e gli accordi quadro, ma i flussi di cassa realmente trasformativi restano opachi.
La matematica della bolla AI
Secondo l’analisi di Matrice Digitale, i ricavi generati dal segmento AI avrebbero dovuto essere già oggi molto più alti per giustificare la dimensione degli investimenti. Per tenere in piedi l’intero castello, si sarebbe dovuto parlare almeno di un trilione di profitti su un orizzonte ragionevole.
Qui nasce la domanda chiave: da dove arrivano davvero i soldi?
Non è chiaro se gli investimenti siano supportati da liquidità reale o se siano costruiti su complesse strutture finanziarie, debito camuffato, leverage occulto e un uso sofisticato degli strumenti di mercato per gonfiare i titoli più strategici. La sensazione è che ci si trovi di fronte a una gigantesca operazione di ingegneria finanziaria, dove il rischio è spalmato ovunque ma la responsabilità concreta è difficile da individuare. La bolla dell’AI, in questa prospettiva, non è solo una bolla tecnologica. È una bolla di fiducia sul fatto che il futuro dell’AI produrrà automaticamente i profitti necessari a ripagare le scommesse di oggi. E se questo non accade, qualcuno rimarrà con il cerino in mano.
Un ecosistema precario tra fusioni e speculazioni
A complicare il quadro ci sono le fusioni, le acquisizioni e le collaborazioni forzate che, negli ultimi anni, hanno ridisegnato l’ecosistema digitale. Grandi gruppi si sono accorpati, altri hanno stretto alleanze condizionate da prestiti, derivati e ingegnerie fiscali, dando vita a un tessuto industriale che poggia su fondamenta fragili. Matrice Digitale aveva già previsto “con largo anticipo” l’insostenibilità economica di un attore come OpenAI, segnalando come l’intero settore vivesse su un equilibrio instabile: da un lato la retorica dell’innovazione salvifica, dall’altro bilanci gonfiati da aspettative e voci contabili difficili da interpretare. In questo scenario, Nvidia è il perno di una catena in tensione: i suoi margini, le sue vendite, la sua capacità di consegna, persino i suoi rapporti con i governi diventano indicatori sistemici. Se il mercato percepisce che la domanda di GPU per l’AI è inferiore alle attese, o che i grandi clienti iniziano a frenare, la reazione può essere violenta e a cascata.
Il paradosso scientifico: tanta potenza, poche cure
C’è poi un paradosso ancora più profondo. Se l’AI dispone davvero di una capacità di calcolo decine di volte superiore all’uomo, perché non vediamo ancora quei progressi che da anni ci vengono promessi, in particolare in ambito medico e scientifico? Malattie complesse, diagnosi precoci, nuovi farmaci: tutti campi in cui ci si aspettava che la combinazione di big data, modelli generativi e supercalcolo producesse risultati a dir poco rivoluzionari. E invece, nonostante le presentazioni e le demo, non assistiamo a cure realmente “disruptive” per i grandi problemi dell’umanità. Molti osservatori rispondono che è “troppo presto”, che bisogna avere pazienza, che i cicli di ricerca e sviluppo sono lunghi. Ma se davvero la potenza di calcolo è così in vantaggio rispetto alle capacità umane, perché questo vantaggio non si manifesta con la stessa forza nei risultati reali? La sensazione è che la narrativa sull’AI abbia corso molto più veloce dei suoi impatti tangibili, soprattutto nei settori in cui il cambiamento avrebbe un valore sociale incalcolabile.
Se cade Nvidia, cade tutto?
Da qui nasce l’enigma centrale: se crolla Nvidia, crolla tutto il sistema?
Da un lato, l’azienda è al centro della catena hardware su cui si regge la maggior parte dell’infrastruttura AI globale. Data center, servizi cloud, hyperscaler, startup di intelligenza artificiale: tutti, in un modo o nell’altro, dipendono dalla fornitura di GPU ad alte prestazioni. Un contraccolpo sul titolo, accompagnato da un cambio di narrativa, potrebbe tagliare i flussi di finanziamento, rallentare gli investimenti e costringere molti attori a ridimensionare i loro piani. Dall’altro lato, c’è una lettura ancora più inquietante: non è escluso che stia prendendo forma una strategia per deprezzare, almeno temporaneamente, la produzione Nvidia, proprio perché la sua posizione sta diventando “troppo forte, troppo potente”. Tutti hanno bisogno della sua tecnologia, ma nessuno vuole dipenderne in modo irreversibile. Un aggiustamento pilotato dei prezzi e del valore azionario potrebbe servire, a qualcuno, a riequilibrare il tavolo. In ogni caso, ciò che è evidente è che Nvidia è stata blindata dall’economia statunitense come asset critico, un’infrastruttura di fatto strategica per lo sviluppo dell’AI globale. Questo la rende contemporaneamente un pilastro e un potenziale punto di rottura.
La grande partita di Apple: attendere il crollo per rientrare in gara
Dentro questa danza di valutazioni e speculazioni, c’è un’altra protagonista silenziosa: Apple. Negli ultimi anni, è stata spesso accusata di essere la società meno innovativa, più lenta sul fronte dell’AI, poco incisiva rispetto ai competitor nel definire il futuro della tecnologia intelligente. E se però questa apparente inattività fosse una scelta deliberata? Se Apple, invece di inseguire la bolla ai massimi, stesse aspettando il momento giusto per entrare “a gamba tesa” nel settore, approfittando di un’eventuale crisi per fare shopping tecnologico a prezzi stracciati? Se la bolla dovesse scoppiare davvero, un colosso con liquidità enorme e un ecosistema già consolidato come Apple potrebbe ricomprare asset, team e brevetti a valutazioni molto più basse, rimettendosi rapidamente in carreggiata e ribaltando la narrazione sulla sua “fine dell’innovazione”. È uno scenario speculativo, certo, ma anche una chiave di lettura che, nel contesto di una finanza sempre più opportunistica, non può essere esclusa.
L’utopia di un mondo connesso e il corpo dimenticato
Sul fondo di tutto questo si agita una filosofia disturbante: l’idea di un mondo in cui gli esseri umani in carne e ossa diventano marginali, dove nessuno sembra più dover lavorare, dove si immagina una popolazione perennemente connessa, orchestrata da piattaforme di AI che gestiscono informazioni, servizi, interazioni sociali. È una visione che stacca l’esistenza digitale dalla vita biologica reale, riducendo il corpo a un dettaglio, a un vincolo fastidioso da superare. In questo immaginario, le piattaforme e i modelli di AI diventano il vero centro del mondo, mentre l’esperienza materiale – il lavoro, il cibo, il tempo, la cura – viene spinta sullo sfondo. Eppure, come la storia insegna, nessuna rivoluzione tecnologica può cancellare il corpo, i bisogni primari, la fragilità umana. È qui che la distanza tra storytelling e realtà diventa più evidente: si parla di mondi sintetici perfetti, ma si ignorano i costi energetici, sociali e psicologici di questo modello.
L’unica etica che nessuno vuole affrontare: quella del mercato
Negli ultimi anni, il discorso pubblico sull’AI è stato invaso da riferimenti all’etica dell’intelligenza artificiale: linee guida, comitati, task force, codici di condotta, manifesti. Filosofi, accademici, teologi, persino sacerdoti sono stati chiamati a discutere di bias, trasparenza, controllo, dignità, futuro del lavoro. Eppure, dietro queste vetrine, l’unica etica che resta sistematicamente fuori quadro è quella del mercato. Poco o nulla si dice delle speculazioni finanziarie che alimentano la bolla AI, della dipendenza delle grandi piattaforme dai flussi di capitale, del fatto che molti dei paladini dell’etica dell’AI sono stipendiati proprio da quelle aziende che hanno tutto l’interesse a mantenere la narrazione attuale. Mentre si discute di algoritmi “giusti” e di modelli “responsabili”, non si affronta mai davvero la questione di chi guadagna, chi perde, chi rischia, chi paga il conto quando una bolla scoppia. È su questo piano che l’etica si fa davvero scomoda, perché mette in discussione non solo i dataset, ma l’intero architrave economico su cui si regge il sogno dell’intelligenza artificiale.
In questo senso, la riflessione di Matrice Digitale mette il dito nella piaga: prima ancora di parlare di etica dell’AI, bisognerebbe parlare di etica del mercato che la sostiene, delle speculazioni che la gonfiano, delle disuguaglianze che rischia di amplificare. Solo allora si potrà capire se quella che stiamo vivendo è una rivoluzione tecnologica sostenibile o l’ennesima grande bolla finanziaria travestita da progresso inevitabile.
Iscriviti alla Newsletter
Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.
Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.