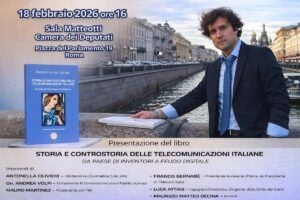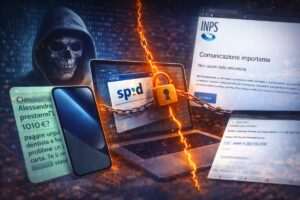La cybersicurezza è entrata ufficialmente nel dibattito politico come ambito di competenza militare, ma è stata freddata nell’immediato. Il disegno di legge depositato dal presidente della commissione Difesa Nino Minardo traduce in norma la linea del ministro Guido Crosetto, ma non del sottosegretario Alfredo Mantovano: riconoscere il dominio digitale come campo di battaglia e dotare l’Italia di una cyberforza armata capace di operare in attacco e in difesa. Ma dietro la veste tecnica si apre una frattura politica che coinvolge Palazzo Chigi, il Quirinale e gli equilibri tra poteri civili e militari.
Il disegno di legge e le nuove regole
Il ddl presentato da Minardo aggiorna le norme vigenti e attribuisce alle Forze armate la possibilità di operare anche in tempo di pace, fuori dagli scenari di guerra tradizionale. I militari potranno condurre operazioni digitali offensive e difensive per proteggere istituzioni, infrastrutture critiche e cittadini, con competenze specialistiche esterne sotto autorizzazioni rigorose e controllo parlamentare. Per la prima volta, viene esplicitata la facoltà di arruolare hacker privati per operazioni cyber di difesa e attacco, spostando l’asse delle competenze verso il ministero della Difesa.
La linea Minardo e l’idea di dominio strategico
Minardo ha rivendicato il lavoro maturato in commissione: indagini conoscitive, audizioni con mondo accademico, vertici militari e istituzioni. L’obiettivo dichiarato è dotare l’Italia di strumenti e garanzie di trasparenza per operare nel cyberspazio, riconosciuto come quinto dominio strategico, al pari di terra, mare, cielo e spazio. Una visione che, nelle intenzioni della maggioranza, mira a inserire la cyberdifesa nell’architettura militare ordinaria, rafforzando la catena di comando della Difesa.
Palazzo Chigi e il freno di Meloni
Il ddl, però, ha suscitato la contrarietà di Palazzo Chigi. Giorgia Meloni non era stata informata della proposta, maturata in sede Difesa senza confronto preventivo. In un contesto politico in cui la premier rivendica il controllo pieno sulla macchina di governo, le fughe in avanti non sono tollerate. Fonti vicine alla presidenza hanno sottolineato che l’iniziativa rischia di alterare gli equilibri istituzionali, soprattutto perché sottrarrebbe competenze all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), oggi sotto la Presidenza del Consiglio e guidata dal prefetto Bruno Frattasi con la supervisione di Alfredo Mantovano nella qualità di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
Il ruolo del Quirinale e i rischi di squilibrio
Anche il Quirinale avrebbe espresso forti perplessità. Figure vicine al presidente Sergio Mattarella avrebbero segnalato i rischi di uno sbilanciamento tra poteri civili e militari, in un settore come la cybersicurezza che riguarda l’intero Paese e non solo la Difesa. Un accentramento eccessivo sotto il ministero militare rischierebbe di ridurre il coordinamento interistituzionale, soprattutto in una fase in cui la guerra ibrida e la propaganda digitale hanno effetti diretti sulla società civile.
La frattura Crosetto-Mantovano
Il disegno di legge porta alla luce un conflitto sotterraneo. Crosetto spinge da tempo per una cyberforza integrata nelle Forze armate, in linea con le esperienze di Paesi che hanno strutture militari dedicate. Mantovano, invece, considera la cybersicurezza un terreno che deve restare sotto la supervisione civile di Palazzo Chigi, in raccordo con i Servizi e con l’Acn. La premier, secondo fonti interne, avrebbe espresso piena fiducia in Mantovano, recapitandogli il segnale politico di uno stop all’iniziativa Crosetto.
Le resistenze nella maggioranza
Nemmeno tra gli alleati il ddl ha trovato terreno fertile. Forza Italia ha fatto trapelare freddezza, giudicando la proposta non prioritaria e potenzialmente divisiva. In un momento di vigilia elettorale, Meloni non intende rischiare fratture su un dossier tecnico ma altamente politico. Per questo, l’indicazione a Crosetto è stata chiara: la riforma non si farà, almeno per ora.
Intelligence, modelli stranieri e il nodo democratico
Dietro la contesa istituzionale si nasconde un nodo più profondo: quale modello di intelligence cyber adottare. L’Italia ha storicamente privilegiato una struttura civile, che facilita collaborazioni e scambio di informazioni con altri Paesi. Crosetto guarda invece ai modelli militarizzati di Stati Uniti e Israele, dove la cyberdifesa è parte integrante della catena militare. L’idea di una cyberforza armata si inserisce in questa visione, ma solleva dubbi sulla tenuta democratica e sull’equilibrio dei poteri. Gli episodi degli ultimi anni – dal caso Pegasus/Paragon alle esercitazioni con partner israeliani ed europei – mostrano che l’Italia non è estranea a pratiche di cyberintelligence condotte anche attraverso privati, seppur spesso in forme poco trasparenti. La dipendenza da infrastrutture straniere, come le piattaforme cloud americane di Microsoft, conferma inoltre i limiti di una sovranità digitale nazionale.
La guerra ibrida e il terreno politico
Il confronto Crosetto-Mantovano va letto anche nella cornice della guerra ibrida, in cui cyberattacchi, disinformazione e propaganda estera giocano un ruolo crescente. L’Italia, come altri Paesi europei, ha sperimentato il peso delle narrative russe, ucraine, anglosassoni e tedesche sul conflitto in Ucraina. La gestione delle informazioni e delle reti digitali diventa così un terreno cruciale di sovranità. La scelta tra un approccio militarizzato o civile alla cyberdifesa è tutt’altro che tecnica: è una questione politica che definisce gli equilibri futuri dello Stato.
Iscriviti alla Newsletter
Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.
Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.